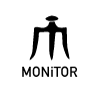Enzo Moscato è il poeta degli stati di eccezione. Epidemie di peste, colera, eruzioni, diluvi, agitazioni, rivoluzioni, invasioni di milizie straniere: non c’è patologia fisica o politica, non c’è disastro, flagello, iperbole della natura o della storia, che non si riversi – Moscato direbbe: che non si sversi – nel ricettacolo capacissimo della sua scrittura. La quale, anzi, presuppone la sospensione dell’ordine, l’esperienza-limite di un tempo fuori-sesto. Non a caso, Moscato spunta dal nulla, come un’eccezione nell’eccezione, nella più tipica delle condizioni aleatorie: il lungo post-terremoto del 1980. Lo fa con un monologo di esordio, Scannasurice, che si apre dichiarando subito la propria preferenza per i mondi inferi, gli immondi, i pozzi neri brulicanti di vita, inevitabilmente bassa e mala, risonanti di squittii di roditori. E opponendo il basso corporeo di questa dimensione sconcia e settica, ma vitale, su cui sporgersi con voluttà e paura, all’altra parte di se stesso, la metà di carta e di scuola. Quella metà disciplinata, dottorale, “alta” ma non meno alienata (di un’alienazione chisciottesca), che riduce tutto il mondo a libro e il teatro a trama, l’uomo alessandrino contro il quale si accanì il sarcasmo di Nietzsche ne La nascita della tragedia: “E accussì ccà sule tre cose nun ce so’ rimaste: gli ipogei, ‘a memoria e ‘a magia… ben sapendo ca sule loro ce putevano salvà… ca sule loro putevano evità le trame, ‘a naftalina, o, peggio, di cadere seppelliti in qualche libbre, alla guisa di mummie alisandrine”. (Scannasurice, 1980-82)
È solo la prima battuta di Moscato che tuttavia, nel trentennio successivo, non smetterà di giocare queste due metà l’una contro l’altra, mettendole in scena con coerenza ammirevole: da un lato, quelle che Pasolini, nella Lettera aperta a Italo Calvino, chiamava le “solitudini al laboratorio”, delle quali si sostanzia la routine dell’intellettuale alessandrino; dall’altro, la consuetudine rischiosa con il mondo delle tenebre, le interferenze di un secondo – meno confessabile – sé, di uno Hyde, per riprendere ancora Pasolini. L’“interferenza cacofonica” di una metà oscura che, nel caso di Moscato, si identifica con tutto ciò che è “iper-napoletano (…): voglio dire la sotto-cultura, la sotto-musica, la sotto-rappresentazione, ovvero il becero, il triviale, il proletariale, il de-sociale, perfino il para-delinquenziale[1]”. Ripeto: questa metà oscura non è, come in Pasolini, un mondo di fuori, un “altro mondo” accessibile solo violando quelle barriere di classe che ne preservano l’innocenza e ne determinano il fascino; è, all’opposto, uno straniero interno, integralmente proprio eppure percepito come un intruso da rimuovere e del quale subire (e forse desiderare o almeno accettare), prima o poi, il ritorno, la recidiva.
La maschera di Moscato, la sua persona scenica, nasce dunque dal combinato disposto di due anime: quella, impeccabile e libresca, del precettore/predicatore/alienista scostante e “igienista”, che pretende di imporre un ordine al caos, e quella, sconveniente, del suo doppio irregolare, del suo negativo plebeo e asinesco che nel caos, nel paesaggio deteriorato, invece ci sguazza, sovralimentandosi di scorie, deiezioni, scarti, di tutto quanto ripugni, faccia senso, alla prima. Ed escrescendo, subentrando quando meno te l’aspetti, come un gonfiore purulento – un “punticcio”, lo definisce Moscato – che è impossibile dissimulare o correggere, per quanto fondotinta retorico ci si applichi.
Il risultato è una maschera comica. Comica e auto-derisoria, auto-sovversiva. Dove il comico risiede nella compresenza e nella tensione, all’interno della stessa persona, di due “sosia parodici[2]” che si contraddicono, si sconcertano a vicenda, presentandosi l’uno come il rovescio dell’altro: sotto la toga/tonaca di Cartesio, che in Moscato personifica l’istanza normativa, sterilizzante e censoria per eccellenza (l’esangue episteme occidentale, ma anche il “moderno” in antitesi alle anticaglie), si nasconde qualcosa di prossimo a un imbarazzante bestione vichiano, robustissimo di senso e di fantasia, incivile, presociale, fuorilegge, la cui memoria, incapace di classificazioni, di gerarchie, di riflessione, non può che essere un immenso accumulo di ciarpame. Un deposito involontario di materiali di risulta, frammenti di immaginario iper-napoletano, quell’immaginario che fa di Napoli un eldorado del camp, delle identità molteplici e mutanti, della sofisticazione e del falso, degli accostamenti innaturali e altamente improbabili, delle alchimie chiassose, tra cavalier Marino e Salone Margherita, Assunta Spina e la Mignonette (senza dimenticare i riusi infiniti ai quali si presta il tragicismo senza tragedia della sceneggiata e di sotto-generi altrettanto banditi ma ai quali Moscato guarda con una pietas che ha equivalenti solo nel “teatro dell’ignoranza” sperimentato a Marigliano da Leo de Berardinis e Perla Peragallo[3]). E questo ben prima che il camp venisse categorizzato dalla critica e i rifiuti, più o meno metaforici, fossero mercificati e spettacolarizzati come opere d’arte. Di qui il ricorso frequente, in Moscato, all’accumulazione, alle elencazioni incoerenti virtualmente infinite, ai moduli di quella tecnica antica della congeries[4] che rimanda tra gli altri a Rabelais, Folengo, Croce (Giulio Cesare, non Benedetto!), l’amatissimo Copi (“omaggiato” in Recidiva, 1995), e che svolge appunto la funzione di tradurre nella sfera verbale l’accozzaglia prodottasi al livello dell’immaginario popolare. Ed evoca un tempo, remoto ma non troppo, nel quale l’abbondanza di parole, la cuccagna fatta di puri nomi, surrogava talora la scarsità di cibo e di altri beni materiali, rientrando in quegli “impossibili sogni di compensazione[5]” che leniscono in parte il dolore della vita: “Un cammeo di Assunta Spina ci ricorda che bastava esagerare agli aggettivi per campare o per essere[6]”.
Quando il ciarpame fuoriesce, facendo sfigurare Cartesio, si ride, come tutte le volte in cui, da Aristofane in avanti, una maestà sia lesa o comunque un rango troppo seriosamente esibito sia cancellato, spernacchiato dal Bertoldo di turno. Ma il legame tra l’infrazione e la regola è stretto. Tanto stretto, parassitario e mimetico, che Moscato chiama il doppio di Cartesio “Carthesiana”, a indicare che i due formano un’entità indivisibile, recto e verso di un’unica maschera.
Sacrifici e abiure
Comica, questa maschera, e tuttavia tragica a caso, per citare un titolo fortunato di Moscato (Fuga per comiche lingue, tragiche a caso, 1990). Sul cui teatro incombe, sempre, la morte. Perché è un teatro segnato fin dall’inizio dal lutto, dalla perdita. Da una confidenza con i morti, i “cosiddetti morti”, che si spinge a convitare in scena, ripetendo, ma volgendolo in senso pietoso, fraterno, il gesto empio – l’invito a cena dell’uom di sasso, la statua funebre del Commendatore – che valse a Don Giovanni le fiamme dell’inferno: è il caso di Compleanno (la prima versione è del 1986, con il titolo Tatuaggi; la definitiva del 1992), festa nera per Annibale Ruccello, a sua volta teatrante grandissimo, o del “breve elenco di lutti-manifesto” (ancora Ruccello e Antonio Neiwiller), in Mal-d’-Hamlé[7] (1994), dove i morti non aprono solo “buchi, faglie, crepe” ma significano “legami, suture, catene”, dunque vincoli stringenti di philia, di amicizia virile, manifesti di chiamata alle armi, oneri per i vivi. Quegli oneri dinanzi ai quali l’Amleto del titolo esitava e che invece gli eroi del tragico antico, determinati ad agire dalle aspettative della comunità dei morti non meno che da quelle dei viventi, adempiono con zelo, assecondando il destino.
Ma non bisogna dimenticare che i trapassati obbliganti, per Moscato, sono fratelli, non padri. Un’orizzontalità anti-edipica contraddistingue i lutti-manifesto. È un punto decisivo. La negazione dei padri – e di uno, in particolare, Eduardo, che personifica l’istanza paterna al massimo grado – è all’origine del teatro di Moscato. Il quale ha poi raggiunto con Eduardo una sorta di pacificazione tardiva – una tregua armata, verrebbe da dire – nel solo modo possibile: quello di scriverci sopra, di inventarselo da pari a pari, senz’alcuna preoccupazione storiografica, alcuna fedeltà documentaria, coprendone gli spazi bianchi, i non-detti e i non-fatti. E coprendone così la fuga dal monumento, come scriveva Roberto De Monticelli, dalla naftalina, dalla celebrazione, dal passato assunto come un dato irrevocabile (in Ta-kai-Ta. Eduardo per Eduardo, 2012, col titolo, in greco classico, che fa pensare a una giostra o al ritornello scemo di una canzone latino-americana). Analogamente, fugge dal monumento e dal libro, in Moscato, una costellazione intera di numi tutelari, riscritti senza deferenza né civetteria iconoclastica ed evocati tutt’al più per frammenti: Copi, di cui si è detto, Artaud (Lingua, Carne, Soffio, 1996), Rimbaud (Aquarium Ardent, 1997), Goldoni (Le Doglianze degli Attori a Maschera, 2007, che presuppone un remoto copione goldoniano originale), lo stesso Shakespeare, fatto reagire con Lautréamont e Pasolini (Mal-d’-Hamlé), Leopardi (Partitura, 1988).
Per tornare all’intimità con i morti, non si entra in comunione con l’invisibile senza un rituale. Ecco perché Moscato, spesso a piedi scalzi come un battente della Madonna dell’Arco, assume in scena la postura del non-attore, di chi non reciti. Nei suoi gesti ci sono, piuttosto, il puntiglio e la misura di chi stia officiando un rito. Un’esattezza fondata sulla ripetizione e attinta a una sapienza riposta, di origine extra-teatrale (ma non anti-teatrale: essendo teatralissima la religiosità popolare). Attinta a una superstizione, forse, che trasforma lo spazio teatrale in un temenos, un luogo di culto e di raccoglimento, separato dal mondo dell’esistenza comune (temenos deriva da temno, “taglio”, “recido”) e nel quale anche il lazzo più osceno partecipa, seppure incongruamente, della solennità di un sacrificio.
Oltranze
La maschera di Moscato, essenzialmente, parla. Straparla. Maneggia e pasticcia lingue su lingue. Un poliglottismo che privilegia – sono parole di Contini[8] su Joyce – il “concatenamento fonico” all’“incatenamento semantico”. E che, sciogliendosi dai vincoli del senso, della consecutio, devia, de-lira dal plot, dalle trame esecrate già nella battuta di Scannasurice da cui siamo partiti. È un’oltranza linguistica malata, quella che si è inventata Moscato. Debitrice delle pirotecnie e dei nonsensi carnevaleschi di un Giulio Cesare Croce ma soprattutto dei contagi ai quali sono naturalmente esposte le città di mare, Napoli in testa. Non c’è dunque inventio linguae, scrive Moscato, che non sia infectio linguae, decomposizione derivante dal contatto col corpo infetto dell’altro (Lingua, Carne, Soffio[9]). Ecco che la maschera mima la glossolalia del malato terminale di peste, il quale dimentica la lingua-madre e diventa un altro, incarnando il senso più profondo del teatro. Quel che la peste toglie, “minorando” – per dirla con Deleuze – la lingua di chi ne è colpito, la peste restituisce, compensandolo con significanti altri e imprevisti.
La libertà dal significato implica dunque, in Moscato, una costante ricerca dell’informe. Una pratica ossessiva di quella che lui chiama avan-scrittura[10]. La scrittura prima della scrittura: gattonante, gesto più che parola. Scrittura sempre accompagnata dall’illusione di far corpo con la vita. Perché l’informe è la vita nel suo nucleo inafferrabile, innominabile: quel nucleo che Artaud chiama forza, in opposizione a forma, e che non si lascerebbe oggettivare in un’opera, qualora fosse possibile coglierlo. E qui, oltre ad Artaud, si profila, dietro il pensiero teatrante di Moscato, la riflessione di Bataille sull’arte come il solo ambito della vita veramente sovrano, perché sciolto da ogni utilità, da ogni “funzione”, inclusa quella del significato.
Eppure, nel gioco (s)combinatorio delle onomatopee e delle allitterazioni, tra i sémi e sèmi sparsi ovunque, può annidarsi, come una perla, la scheggia di una favola. Dal nulla della significazione può affiorare lo scandalo di un cunto. E con un colpo di coda contraddire tutto questo. Scoronando il pensiero teatrante e le sue matrici nobilissime. Irridendo l’autorità paradossale delle filosofie che lo sorreggono prima che queste diventino di maniera, diventino catechesi, scolastica. Perché l’anomalia-Moscato a Napoli e sulla scena italiana consiste in un’arte dell’abiura o della fuga senza fine. In primo luogo da se stesso.
[1] Moscato E., Appunti da La Psychose paranoïaque parmi les artistes ovvero Ritorno a Carthesiana per un controllo clinico-metodologico e Preparazione al Karma di Madame la Recherche, Flavio Pagano, Napoli, 1993, p. 8.
[2] Celati G., Finzioni occidentali. Fabulazione, comicità e scrittura, Einaudi, Torino 2001, p. 115.
[3] Manzella G., La bellezza amara. Il teatro di Leo de Berardinis, Pratiche, Parma, 1993, p. 49.
[4] Del cui comicissimo “effetto di cascata dal rumore stordente” ha scritto Garavini F., Parigi e provincia. Scene della letteratura francese, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, p. 33.
[5] Camporesi P., Il pane selvaggio, Garzanti, Milano, 2004, p. 5.
[6] Moscato E., Litoranea, scritta per Toni Servillo, in Rasoi, 1991, regia di Mario Martone.
[7] In Id., Quadrilogia di Santarcangelo, Ubulibri, Milano, 1999, p. 39.
[8] Contini G., “Espressionismo letterario”, in Id., Ultimi esercizî ed elzeviri. 1968-1987, Einaudi, Torino, 1989, p. 83.
[9] In Quadrilogia di Santarcangelo, cit., p. 91.
[10] Moscato E., Carnaccia. Avan-scrittura per 7 numeri e 21 vocali e consonanti, Edizioni d’if, Napoli, 2013.