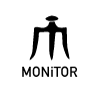Il settore non for profit in Italia è un variegato mondo di organizzazioni molto diverse tra loro. Nel paese, almeno dalla Liberazione, vi è un insieme di tradizioni nobili che hanno ispirato realizzazioni esemplari. Si può ipotizzare che nelle traiettorie della modernizzazione italiana, in un paese che in buona parte delle sue regioni ha conosciuto un welfare ridotto, squilibrato (maschilista, gerontocratico, lavorista e poco attento al sud), lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore ha espresso i particolari caratteri del tentativo di europeizzazione dell’Italia.
La fotografia dell’Istat
In letteratura e nei testi normativi vengono utilizzate diverse definizioni di attività non profit: organizzazioni non lucrative, di volontariato, terzo settore, economia sociale. Si tratta di una varietà di azioni organizzate, sviluppate in Italia dagli anni Settanta pur avendo per alcuni comparti radici antiche e di grande prestigio[1].
I rilievi più recenti sono stati fatti dall’Istat, che ha presentato una fotografia desunta dal censimento delle organizzazioni non profit al 2011, con confronti fatti con i dati del 2001[2]. In generale, notiamo un elevato ricambio nel corso del decennio: circa la metà delle organizzazioni attive nel 2011 non esisteva dieci anni prima, con una forte crescita occupazionale (+61,5% nel decennio) registrata soprattutto nelle istituzioni storiche (+31,3%) e grazie all’emersione di organizzazioni già esistenti (+18,6%)[3].
Per il settore non profit, al 2011, l’Istat ha censito 301.191 organizzazioni che godono del contributo operativo, lavorativo di 4,7 milioni di volontari, quasi 681 mila dipendenti, 270 mila lavoratori esterni, 5 mila lavoratori temporanei. Il 37,3% di tali enti sono istituzioni mutualistiche, organizzate per offrire servizi ai soci, mentre la maggioranza sono organizzazioni di pubblica utilità, che non selezionano quindi i beneficiari se non in base al bisogno. Tra gli addetti ricorre la maggioranza femminile, con il 67% dei lavoratori. Questa maggioranza di genere, che non è presente nei ruoli apicali, è un segno della prevalenza di impegni nell’assistenza sanitaria e socio-educativa di molte di queste organizzazioni, che di fatto svolgono un ruolo di supplenza per i servizi pubblici che lo stato non riesce a fornire da solo. Tutti gli indicatori evidenziano una crescita rispetto al 2001, soprattutto la grande quota di lavoratori esterni (+169,4%). Crescita certamente attenuata per la crisi degli ultimi anni che verrà registrata solo con successivi rilievi.
Le attività interne all’assistenza sanitaria assorbono la maggior parte delle risorse. Accanto a una significativa diffusione, forse polverizzazione, è evidente però una significativa varietà di settori e comparti, forme giuridiche, taglie delle unità locali, modelli organizzativi, figure sociali, forme di finanziamento, radici e riferimenti culturali.
Mentre in termini di numero di organizzazioni prevale una tipologia economica riferibile a organizzazioni non di mercato (quasi il 70%) a prevalente finanziamento privato (86,1% delle istituzioni), rispetto al numero di addetti prevalgono le organizzazioni di mercato con il 57,8% degli addetti in enti sostenuti con prevalente finanziamento pubblico.
Dalle analisi risulta che solo un terzo delle organizzazioni realizza forme di partenariato, in gran parte dei casi con istituzioni pubbliche, nell’ambito di convenzioni. Proprio la questione del lavoro di rete territoriale e della capacità di realizzare convergenze con altri soggetti simili, è una delle questioni nodali del modo di fare di queste organizzazioni[4].
Rispetto alla distribuzione geografica per tutti gli aspetti (numero di istituzioni, unità locali, addetti e volontari), poco più del 50% di queste realtà sono concentrate al nord, poco più del 20% al centro e solo il 20-25% al sud o nelle isole. Emerge con evidenza l’associazione tra forza dell’economia e del tessuto istituzionale locale, come della tradizione civica organizzata da un lato, e presenza del tessuto associativo dall’altro. Questo vale anche scontando una quota di non emerso sfuggito ai rilievi fatti dall’Istat. Soprattutto il numero di addetti e di volontari al Sud è significativamente inferiore alle medie nazionali e ai valori assunti in alcune regioni del centro-nord.
I dati sulle forme giuridiche indicano che è prevalente l’associazione non riconosciuta, la formula più semplice e snella (66,7%), mentre quelle riconosciute con un decreto del presidente della repubblica sono poco più del 22%. Le fondazioni, molto aumentate nel decennio considerato, sono solo il 2% dell’insieme e le cooperative sociali – vera peculiarità dell’esperienza italiana – sono il 3,7% dell’insieme.
Tutte queste organizzazioni aggregherebbero 56 milioni di persone fisiche, più o meno coinvolte e mobilitate. Anche in merito ai volumi delle entrate monetarie è evidente il divario: al nord-ovest il 37,6%, al nord-est il 18,5%; il 31,8% al centro e solo il 7,3% al sud e il 4,8% alle isole. Il tutto per un flusso di incassi pari a quasi 64 miliardi di euro. La Fondazione con il Sud, che ha il mandato di occuparsi delle sei regioni meridionali, ha un patrimonio di 400 milioni con una capacità erogativa di 20 milioni annui. La fondazione ha erogato in sette anni di vita 110 milioni di euro, sostenendo oltre 500 iniziative, coinvolgendo circa 5.000 organizzazioni del terzo settore, che hanno raggiunto circa 170.000 beneficiari, 41% dei quali minori. Pur ricordando che al sud vi sono altre fondazioni di origine bancaria, tutte con dotazioni medio-piccole (Banco di Napoli, Caripuglia, CariCal, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna), il divario è evidente considerando che, complessivamente, quelle operative nelle altre regioni del centro-nord hanno un patrimonio di 42 miliardi e fanno erogazioni per circa 900 milioni all’anno.
La parabola delle politiche sociali
La crescita negli ultimi venti anni delle organizzazioni non profit è fortemente associata alla traiettoria che hanno avuto le politiche sociali nel nostro paese. Nella prima metà degli anni Novanta si apriva una stagione promettente, l’inizio di una progressiva europeizzazione delle politiche del welfare alla scala locale, che si supponeva dovesse essere governato con un’apertura dei processi decisionali e attraverso il coinvolgimento degli abitanti interessati dagli interventi.
Per le politiche sociali, animate da un rinnovato sguardo al territorio, è stata una stagione molto fertile. Diversi gli strumenti messi in campo: la legge sul volontariato 266/91; la legge Iervolino 216/93, che ha finanziato interventi in favore di minori in zone ad alto rischio sociale; e ancor più la legge Turco 285/97, che ha finanziato e imposto ai comuni piani per l’infanzia e l’adolescenza; fino alla legge quadro 328/2000, in parallelo con riforme di sistema quale l’elezione diretta dei sindaci e consistenti programmi europei (Ppu e Urban soprattutto). La crescita delle organizzazioni non profit è stata sollecitata dalle opportunità che queste leggi hanno offerto, proprio perché pensate e scritte avendo presente le potenzialità di questo tessuto associativo.
Oggi si può dire che si è trattato del punto massimo di una curva che poi ha cominciato una lenta discesa, l’apice di una visione che in pochi anni è stata svilita, con sempre più severi tagli alle risorse e un ritorno alla tradizionale logica dei servizi, con poca capacità di apprendimento da parte dei responsabili del governo locale verso un approccio di tipo integrato e partecipato. In diversi contesti si è tornati a logiche di tipo pauperistico, non solo per l’aumento di persone in condizioni di necessità che hanno posto domande essenziali come mangiare in una mensa, dormire in un dormitorio o avere i soldi per pagare le bollette, ma anche per la riproposizione da parte di organizzazioni, laiche e cattoliche, locali e internazionali, di un approccio non teso a riconoscere diritti ma a trattare domande di carità.
Rispetto all’attuale modello di welfare italiano, si può ipotizzare un forte nesso tra crescita di attività e di operatori del settore non profit e precarizzazione del lavoro nei servizi alle persone e alla cura del patrimonio. Di fatto, una parte consistente dei lavoratori impiegati in queste organizzazioni svolge lavori che dovrebbero essere assicurati da operatori remunerati direttamente dalla spesa pubblica, anche se non necessariamente interni ai ruoli pubblici, contrattualizzati e pagati però in modo regolare e non precario e flessibile come avviene oggi.
L’involuzione del lavoro sociale
Le esperienze e gli studi degli ultimi venti anni di politiche urbane hanno dimostrato che la sofferenza urbana si concentra nelle periferie sociali (spesso fuori le mura ma, soprattutto nelle città meridionali, anche al centro della città). Già alla base della legge 216, che nel 1991 stabiliva finanziamenti per attività in favore dei minori in zone ad alto rischio sociale, vi era un approccio segnato dalla consapevolezza che in poche decine di territori bisognava riconvertire le dinamiche che producono in massa copioni di esclusione sociale.
Nelle periferie sociali, diverse decine di organizzazioni svolgono da anni attività di prevenzione e protezione sociale, in nome e per conto di enti pubblici e/o di alcune fondazioni. Con alterne vicende, hanno realizzato politiche di sviluppo di comunità, riducendo i danni dell’esposizione di migliaia di persone a condizioni di disagio spesso grave. A partire da un’impostazione di volontariato negli anni Settanta, mutata poi per la maturazione delle iniziative locali, hanno svolto un ruolo di supplenza e stimolo delle amministrazioni locali che in realtà, pur avendo realizzato alcune politiche innovative, non hanno quasi mai realizzato un welfare urbano idoneo alle condizioni di vita nelle periferie sociali del meridione.
Negli anni molte cose sono cambiate: l’età dei promotori delle associazioni, il profilo sociale degli operatori, il posizionamento dei dirigenti degli enti locali, il ruolo giocato dalle fondazioni e soprattutto quello svolto dagli enti locali e dalle istituzioni europee. In sintesi, pur realizzando esperienze significative, si può dire che buona parte del lavoro svolto dalle agenzie sociali è stata una sostituzione che ha deresponsabilizzato gli enti pubblici, che hanno esternalizzato servizi a basso costo favorendo non di rado gruppi di organizzazioni in parte sottomesse e poco capaci di attivare le persone, i beneficiari dei servizi.
In diversi casi, soprattutto nel primo periodo, si è trattato di iniziative che hanno fatto scuola proponendo modalità di intervento realmente innovative. Nel tempo, in molti territori il modello si è banalizzato. Quasi sempre i servizi sono stati affidati con avvisi pubblici e bandi di gara che hanno appena riconosciuto, e non sempre, le spese indispensabili per realizzare i servizi. Aggiungendo a ciò gli oneri finanziari per anticipare alcuni costi indifferibili, da aggiungere a quelli economici e umani per i gravissimi ritardi nei pagamenti, si può dire che la buona volontà messa a disposizione dalle agenzie sociali – i cui dirigenti e operatori non sono immuni da responsabilità – è stata ripagata obbligando in modo fittizio e ipocrita al cofinanziamento e alla condivisione di un debito tenuto in ombra. Parte di tale debito è stato pagato da operatori sfruttati e/o costretti a rinunciare a parte della remunerazione. Altra parte è stata coperta da molto lavoro volontario, di fatto sostitutivo del lavoro da remunerare. Resta ancora una quota cospicua, che ancora non si sa chi pagherà. Ancora peggio è che queste condotte hanno determinato l’esaurimento di speranza, fiducia, motivazione. Numerosi operatori ben qualificati dopo quindici o venti anni di lavoro sociale sono stati costretti a fare la scelta di andare a lavorare al nord, oppure hanno cercato lavoro meno qualificato ma almeno minimamente pagato.
Senza sottovalutare dei buoni sussulti, spesso sollecitati da politiche europee o da politiche quadro, si può dire che in Italia le politiche per le periferie sono state riconficcate alla periferia delle politiche. In questo scenario, anche il ruolo delle varie fondazioni non è immune da errori e responsabilità. Spesso le finalità che orientano tali fondazioni sono la promozione di un marchio, l’inserimento nell’agenda delle politiche, la visibilità nei pertinenti settori di opinione pubblica, la costruzione di consenso attraverso partenariati sempre più affollati, senza nascondere la necessità di conquistare spazi nel mercato delle risorse pubbliche per coprire i costi dei loro dipendenti. Un errore tipico delle fondazioni, per esempio, è quello di proporre sempre iniziative nuove – che sarebbero solo per questo “innovative” – per distribuire finanziamenti a pioggia, in genere prescindendo da quello che già esiste nei territori e dalla necessaria opera di razionalizzazione, manutenzione e valutazione, e magari dal rilancio di quello che già esiste.
In anni recenti sono state realizzate nei quartieri popolari iniziative lodevoli quanto necessarie, anche grazie a politiche pubbliche e/o cofinanziate da fondazioni. Da alcuni anni però è forte la sensazione di una svolta, maturata nella cornice di una profonda crisi – innanzitutto culturale, oltre che economica del welfare –, che ripropone pratiche assistenziali ove si confonde l’innovazione con il finanziamento di progetti occasionali, in competizione tra loro, che ripropongono l’immagine del “povero meritevole”, da aiutare solo nella misura in cui non demerita un servizio, accanto a quella della “agenzia meritevole”, con ottima reputazione, inventiva, creatività, capacità di comunicazione, di spesa e di cofinanziamento.
Una declinazione più promettente della partecipazione è quella secondo cui le persone vengono sostenute per fare insieme le cose direttamente pertinenti alla loro vita. Qualche studioso americano ha parlato di empowered partecipation: un approccio che ritiene indispensabile una qualche forma di protagonismo dei beneficiari delle politiche, implicando anche una loro responsabilizzazione. Un approccio che ha rilevanti testimoni già nella storia italiana degli anni Cinquanta. Va detto però che queste politiche si possono realizzare solo con finanziamenti idonei, tempi lunghi, valutazione ben fatta, superando l’orientamento superficiale che oggi ispira diversi bandi e politiche pubbliche.
[1] Si pensi alle organizzazioni delle camere del lavoro trattate in Ferraris P., Ieri e domani. Storia critica del movimento operaio e socialista ed emancipazione dal presente, Edizioni dell’Asino, Roma, 2011.
[2] Nel sito dell’Istat sono consultabili i dati riferiti alla rilevazione delle istituzioni non profit nell’ambito del 9° Censimento dell’industria e dei servizi con riferimento alla situazione al 31/12/2011 e con diverse analisi fatte da esperti tra cui quella di Barbetta G., Lorenzini F., Mancini A., Struttura e dinamica del non profit in Italia, Istat, presentata nel convegno svolto il 16/04/2014.
[3] Cfr. Barbetta G., Canino P., Cima S., Crescita occupazionale e nuove istituzioni, Istat, presentata nel convegno svolto il 16/04/2014.
[4] Cfr. nel sito dell’Istat, tra le presentazioni fatte nel convegno svolto il 16/04/2014, quella di Rossi G., I processi reticolari delle istituzioni non profit.