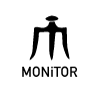Il piano regolatore è “atto amministrativo volto a determinare la configurazione del territorio comunale”, così recita l’enciclopedia Treccani. Equivale a una legge che ogni comune si dà per disciplinare la possibilità o meno di edificare – o trasformare se già edificato –, tutelare beni storici e naturali, riservare gli spazi necessari alla vita pubblica e, in genere, alle esigenze dei cittadini. Perciò si rappresenta mediante norme e mappe che dividono il territorio in zone distinte per usi e interventi ammessi, e con misure più o meno variabili di ciò che si può o meno fare; a questo scopo il “piano”, come lo chiamano gli specialisti, presuppone la conoscenza approfondita del territorio – abitanti compresi – e un’idea del suo futuro prevedibile.
Più prosaicamente, il piano costituisce un compromesso tra le forze dominanti di una città, aperto alle istanze dei cittadini nella misura consentita da forza e qualità della democrazia. Ancor più prosaicamente, spesso funziona come un testo da interpretare, di modo che ciò che non è previsto si può fare, oppure che una previsione può realizzarsi attraverso un rito abbreviato. Rifare un piano o anche solo variarlo è troppo impegnativo per chi governa la cosa pubblica: costa democrazia. Così accade che in momenti cruciali della prassi di governo del territorio, si agisca mediante un uso estensivo della deroga – in origine facoltà circostanziata – per prendere decisioni senza renderne conto attraverso più impegnativi processi democratici. Poi ci sono le varianti imposte, di fatto, da brutali rapporti di forza, per esempio quelle prodotte dall’abusivismo edilizio e dal circuito perverso abuso-condono-abuso. Insomma, tanto questa speciale legge è invocata, quanto è disincantato il suo rispetto, e di tale volubilità sono maestri quelli che, mentre amministrano l’eccezione del momento, si proclamano sacerdoti del piano che verrà, quello bello e giusto e, finalmente, vero ed esatto.
Introdotto l’argomento, passiamo a un sintetico stato dell’arte della pianificazione urbanistica a Napoli e dintorni, per poi proporre qualche osservazione nel merito.
Un lungo percorso
Nel giugno 2004 la Regione approva la variante generale al piano regolatore generale (Prg) di Napoli, che, unita alla variante per la zona occidentale approvata nell’aprile del 1998, sostituisce per intero il vecchio piano del 1972, rivelatosi di fatto inattuabile. Rinviando altrove per una più ampia ricostruzione storica, qui basta dire che, con il nuovo piano regolatore, termina una lunga stagione di sostanziale indisciplina urbanistica, culminata, dalla metà degli anni Ottanta, nell’uso spinto all’eccesso di poteri derogatori. Ne sono testimonianza, in particolare, le grandi infrastrutture realizzate mediante la legge di ricostruzione post-terremoto, soprattutto nell’area metropolitana, e le opere per i mondiali di calcio del 1990.
Il primato della “regola condivisa” come condizione e garanzia dell’operare: questo è l’approdo di spinte diverse catalizzate nel movimento civile sorto nel ’93 intorno alla vicenda di Tangentopoli (l’insieme di casi di corruzione pubblica e privata rivelato dalle inchieste giudiziarie sul decennio precedente). Una sorta di “compromesso storico municipale” nel quale convergono l’esigenza degli imprenditori alla ripresa dell’edilizia, l’aspettativa diffusa di uno sviluppo urbano animato dalla cura della città intesa come un bene in sé prezioso, la formazione di una nuova leadership cittadina intorno al sindaco eletto direttamente dal popolo, unica innovazione politica introdotta a seguito di Tangentopoli. Detta in estrema sintesi, la sostanza del cambio sta nel tentativo di fuoriuscita dalla tradizionale pratica del doppio binario di regola e deroga: la prima per vietare e la seconda per fare, secondo una loro ipocrita accezione.
Quanto il cambio sia riuscito è materia di analisi attuale, su cui torneremo più avanti; nel merito, azzardiamo una sintesi dei suoi contenuti. La memoria del piano precedente, che rinviava l’attuazione di previsioni fondamentali a successivi piani esecutivi, ha spinto a dettagliare la disciplina tanto che la norma urbanistica si attua direttamente con autorizzazione edilizia nel 72% della zona occidentale e nell’87% del restante territorio comunale. Il principio generale è che laddove si tratta di conservare e riqualificare, come nei tessuti storici, si privilegia l’attuazione diretta, mentre per la trasformazione di aree destinate a nuovi assetti e usi, come quelle industriali dismesse, gli interventi sono subordinati a piani urbanistici esecutivi.
Nelle intenzioni conservazione e trasformazione concorrono a realizzare una superiore qualità urbana e ambientale, considerando chiusa la possibilità di ulteriori espansioni. Il modello di riferimento è la città europea post-industriale, caratterizzata dalla produzione di servizi più che di beni, e da strutture sociali “fluide” per le quali mobilità e accessibilità sono condizioni indispensabili, anzi valori. Infine, il motore della strategia sottesa al piano starebbe nella trasformazione delle aree dismesse, da realizzarsi sotto la direzione pubblica e, in gran parte, per mezzo di attori e capitali privati, data la progressiva caduta dell’intervento pubblico.
In ultimo, ma non per importanza, resta da dire della costruzione del nuovo piano regolatore avvenuta per passi successivi, intervallati da pubbliche consultazioni: dopo la definizione degli indirizzi generali (’94), la cosiddetta variante di salvaguardia (’95/98) che attiva anche prime possibilità d’intervento in zone tutelate e, soprattutto, la variante per la zona occidentale (’96/98), motivata dall’urgenza di avviare bonifica e riconversione delle aree dismesse di Bagnoli; poi i dibattiti pubblici su distinte proposte di zona, culminati nell’adozione della variante generale (2001); il tempo successivo è stato impegnato dalle più rituali prassi delle osservazioni e del confronto con l’amministrazione regionale.
Nel dicembre 2004 il consiglio regionale approva la legge 16, che detta norme per il governo del territorio. Viene ridefinita l’architettura generale della pianificazione, con al vertice il piano territoriale regionale (Ptr), seguito dai piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp) e, alla base, dai piani urbanistici comunali (Puc). Livelli che preesistevano, ma si stringono le loro relazioni e, in particolare, cambia la pianificazione comunale, le cui procedure di formazione vengono snellite, senza benefici di trasparenza e, soprattutto, con sacrificio delle garanzie che, mentre la proposta di piano compie il suo percorso, non vi siano interventi che possano vanificare nuovi vincoli e previsioni (si tratta delle “norme di salvaguardia”, i cui termini sono abbreviati).
Cambia anche la forma del Puc che si compone delle disposizioni “strutturali”, valide a tempo indeterminato, e di quelle “programmatiche”, che ogni tre anni precisano le condizioni di determinati interventi pubblici e privati; inoltre, il Puc è accompagnato da un regolamento urbanistico edilizio comunale.
La spinta allo snellimento investe anche i piani attuativi (prima detti esecutivi) che vengono approvati direttamente dalla giunta comunale, mentre prima passavano al vaglio del consiglio; inoltre, viene sancito che nella loro attuazione venga seguito un criterio, detto di perequazione, finalizzato all’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri di urbanizzazione tra i proprietari degli immobili oggetto di trasformazione. A proposito dell’attuazione dei piani urbanistici attuativi (Pua), sono disciplinate le società di trasformazione urbana (Stu) – strutture delegate a realizzare gli interventi – vincolandole alla preminenza del capitale pubblico.
Nell’insieme l’intento appare quello di allinearsi a modelli vigenti in altre regioni, magari accentuando l’attenzione alle istanze del mercato, vale a dire di proprietà immobiliare e costruttori. Comunque, passano pochi anni e la legge cambia in punti significativi. Prima con correzioni inserite nel mezzo di leggi per un cosiddetto “piano casa”, poi con un regolamento approvato dalla sola giunta regionale nel 2011, si ridefiniscono i procedimenti di formazione dei piani e si rendono più stringenti i rapporti tra i livelli della pianificazione (territoriale e comunale), anche introducendo ulteriori abbreviazioni di termini. Il comune ricorre contestando che un regolamento possa cambiare norme già fissate dalla legge, e la contesa viene rimessa alla Corte costituzionale.
La nuova legge regionale non ha prodotto sostanziali miglioramenti nel governo del territorio: approvato il Ptr nel 2008, invece non è ancora vigente il Pct della provincia di Napoli, la cui proposta sta nel tunnel di una procedura di formazione iniziata diciotto anni fa; intanto, una legge nazionale (56/2014) riconverte la provincia in “città metropolitana” e introduce nuovi strumenti di pianificazione, azzerando di fatto la situazione precedente; infine, in tutta la regione, non più di un comune su dieci ha approvato il Puc previsto dalla legge regionale.
Insomma, focalizzando sull’area napoletana, lo stato di salute della pianificazione non è migliorato: la gran parte dei piani comunali risale al secolo passato (57 su 92), in alcuni casi si tratta solo di atti di regolamentazione edilizia; solo cinque comuni si sono dotati del nuovo Puc; territori comunali popolati come città (da 50 a 120 mila abitanti) sono amministrati con piani che risalgono agli anni Ottanta – come Acerra, Casoria, Giugliano e Marano – o addirittura ai Settanta – come Afragola, Ercolano e Torre del Greco; infine, l’età media di gran parte dei piani supera i vent’anni[1]. Una strumentazione almeno imperfetta e, in larga misura, senescente dovrebbe disciplinare l’uso del suolo nell’area di più antica e densa urbanizzazione in Europa e, oggi, una delle metropoli più rilevanti. Missione impossibile, verrebbe da dire.
Dal piano casa allo Sblocca Italia
Mentre la pianificazione giace, s’avanza la deroga. Nel 2008, l’ultimo governo Berlusconi vara il già citato piano casa: una serie di misure straordinarie per favorire l’edilizia abitativa, da attuarsi mediante leggi regionali. È appena iniziata la recessione globale e per uscirne ci si affida all’edilizia, il più classico strumento di rianimazione dell’economia, con la differenza che invece che al tradizionale intervento pubblico si ricorre a deroghe temporanee alle norme urbanistiche, contando che ciò mobiliti proprietà immobiliare e costruttori.
La Campania, con la legge 19/2009, vara un piano casa che, in estrema sintesi, consente un variegato insieme di deroghe per ampliamenti e sostituzioni edilizie, anche con cambio di destinazione dall’uso produttivo o terziario a quello residenziale; inoltre, prevede interventi di scala più ampia in zone urbane degradate e programmi per edilizia residenziale sociale, cioè abitazioni in fitto o in vendita a prezzo ridotto. Nelle pieghe della legge, prorogata nel 2011, passano anche misure di sostanziale sanatoria di opere irregolari, oltre ai citati rimaneggiamenti della legge urbanistica.
Stando ai risultati noti, il piano casa ha prodotto più interventi edilizi puntuali che le auspicate trasformazioni di aree urbane degradate, tantomeno risulta nel mercato delle abitazioni un’offerta significativa di edilizia sociale. Almeno in questo caso, le opportunità offerte dalle deroghe non hanno mobilitato granché.
In chiusura della rassegna su azioni rilevanti di governo del territorio, è necessario citare il decreto detto Sblocca Italia (legge 164/2014), che dispone, oltre a nuove semplificazioni delle norme edilizie, misure per accelerare la realizzazione di infrastrutture e grandi interventi, tra questi la bonifica e la trasformazione dell’area dismessa di Bagnoli-Coroglio, di cui letteralmente s’appropria.
Quando il governo interviene, le aree ex Ilva sono sequestrate per un’inchiesta giudiziaria sulla loro bonifica, della Stu Bagnolifutura è stato dichiarato il fallimento, le poche opere realizzate sono fuori uso. A fallire è la trasformazione dell’area dismessa dal ’92, un processo avviato con la variante urbanistica del ’98, esito di un’aspra contesa tra enti locali per la primazia sulla guida dell’operazione e le sue finalità; ne sortisce un piano dall’immagine fortemente ambientalista: al centro un parco grande quanto l’acciaieria dismessa, affacciato su una spiaggia da far riemergere, intorno insediamenti a bassa densità con strutture tipiche della civiltà post-industriale.
Nel 2001, il comune, a risarcimento del passato inquinamento industriale, acquisisce le aree che vanno a formare il capitale di Bagnolifutura, società incaricata di bonificare oltre che di trasformare; viene approvato il piano urbanistico esecutivo (2005), la cui attuazione, in seguito, è limitata a interventi rilevanti ma puntuali, mentre non s’attiva il processo ipotizzato: prima le urbanizzazioni fondamentali, poi gli interventi privati sulle distinte aree. Intanto, la bonifica diventa un meccanismo che si autoalimenta e brucia risorse, mezzo miliardo di euro secondo una stima approssimata. Così si arriva all’esito descritto in premessa, cioè si chiude il cerchio e la primazia torna allo stato che, attraverso il governo, dispone su tutto: bonifica ambientale e rigenerazione urbana. All’operazione sono preposti un commissario straordinario e un soggetto attuatore, cui sono trasferite le aree e tutti i compiti: dalla proposta di bonifica e trasformazione all’appalto dei lavori; la decisione è sottoposta a una conferenza di servizi o, in caso di disaccordo, al governo; il programma approvato costituisce “variante urbanistica automatica”. E il comune? In fase consultiva può avanzare proposte, di cui l’attuatore esamina la coerenza con le proprie, infine decide il governo. La decisione assorbe ogni altro parere e intesa, nemmeno prevede qualche procedura consultiva oppure obblighi di trasparenza e informazione pubblica. È assoluta. Che sia fallita una trasformazione urbana può accadere, come che il governo locale sia commissariato, ma che sia sacrificata la democrazia è una ferita che nessun eventuale buon progetto risarcisce.
Considerazioni finali
A Napoli, il cambio promesso dal piano è dimezzato dallo stallo della trasformazione delle aree dismesse. Alla radice dello stallo c’è altro, oltre le imperfezioni tecniche. In una società plurale e conflittuale come la nostra, se un po’ per volta si scivola in un regime di democrazia ridotta (vedi l’esito di Bagnoli), grandi trasformazioni urbane, comunque progettate, non risultano efficaci né riescono a incontrare le attese dei cittadini loro destinatari. Com’è pensabile che piani e progetti procedano da soli, senza una mobilitazione sociale ben più ampia della cerchia dei soggetti interessati? Lo strumento della mobilitazione sociale è la democrazia.
Nel recente passato, l’iniziale sussulto civile s’è poi sopito nella prassi di una politica normalizzata, arte del governo e del consenso che non ha voluto o saputo aprire spazi a innovazioni democratiche, da maturare nell’esperienza in occasioni meno risicate di quelle concesse, magari per tentativi-errori-correzioni. Che cosa, nelle trasformazioni urbanistiche e in quelle più generali, sterilizza la democrazia? Idee sbagliate e interessi perversi della “mala politica”? Sì: è la risposta più frequente, ma è sufficiente? Oltre alla cattiva politica, oppongono inerzia più articolati blocchi di potere che vegetano nella stasi economica e sociale, e paradossalmente se ne alimentano. L’area napoletana versa in recessione da prima del fatidico 2008, condizione che ha ridotto la mobilità sociale e, anche ai piani alti, il campo degli attori. Oggi in urbanistica vegeta, come una pianta più di altre resistente alle intemperie, chi concentra il possesso di beni strategici come immobili e danaro, chi detiene poteri di disposizione politico-amministrativi o può influire su di essi, chi ha accesso privilegiato alla spartizione di risorse e opportunità, compresi appalti e incarichi. Ciò è evidente in formato micro in qualsiasi paese e, in quello macro, è il sistema destinato a costruirsi intorno al progetto Bagnoli versione Sblocca Italia. In recessione, invece, sono spinti ai margini i gruppi sociali più deboli, come il popolo delle periferie, marginale nella spartizione delle risorse urbane, tuttalpiù oggetto di compassionevole attenzione. È un fatto che gli ultimi significativi programmi urbanistici nelle periferie napoletane risalgano al secolo passato, come che, esaurite le traversie post-terremoto, sia disconosciuta l’esistenza di una questione abitativa.
Che c’entra la pianificazione in tutto questo? Il piano, inteso come parte di una più ampia strategia politica, non può ridursi a promessa, ma deve agire nei rapporti tra tutti gli attori per mobilitarli e indurli al confronto, attivandone di nuovi e, infine, cambiando l’assetto di potere consolidato. La pianificazione, se resta chiusa in ragnatele istituzionali, riducendo la partecipazione a un gioco formale, spesso finisce per incartarsi in tecnicismi, alimentando le pratiche derogatorie (lo testimonia l’esperienza regionale); deroghe di vario tipo, che in sé non fanno scandalo, ma fa danni il fatto che costituiscano alibi per assumere decisioni in condizioni di democrazia ridotta; come fa danni l’incapacità a chiudere i conti con l’abusivismo.
Le questioni di merito restano fuori da questa informazione commentata sullo stato della pianificazione, qui basta osservare che le “magnifiche sorti e progressive” della città post-industriale s’infrangono contro la recessione globale e l’incertezza di ogni prospettiva. Sarebbe saggio impegnarsi in un inedito sforzo d’invenzione. È plausibile che questo sforzo possa prodursi senza mobilitazione sociale e più ampi spazi democratici? Di certo no.
[1] Santoro M., Natura della politica locale e scelte urbanistiche, 2015.