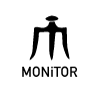Nel luglio 2014, il ferimento a colpi d’arma da fuoco di due ragazzi ghanesi a opera di un giovane italiano e l’immediata e violenta reazione della comunità africana, furono all’origine, il giorno seguente, di due manifestazioni contrapposte: da un lato, un gruppo di italiani bloccava la Domitiana denunciando gli africani, secondo loro responsabili di numerosi furti, della prostituzione e della vendita di droga sul territorio; dall’altro lato, al centro di Pescopagano, un gruppo di africani occupava la strada principale sostenendo che i due ragazzi erano stati colpiti senza motivo, denunciando a loro volta di essere trattati come bestie, guardati con disprezzo e sfruttati come manovalanza per i lavori più umili. Il governo intervenne nuovamente inviando forze di polizia e carabinieri[1] e rimandando a un secondo momento gli interventi strutturali per migliorare le difficili condizioni di vita delle persone che abitano lungo la Domitiana.
È indubbio che l’uccisione di sei ragazzi africani nel 2008, i tanti episodi di razzismo, piccoli o grandi, accaduti in questi anni a Castel Volturno, ma anche in altre parti d’Italia – molti dei ragazzi che vivono a Castel Volturno durante l’anno si spostano temporaneamente in altri luoghi in cerca di lavoro – hanno profondamente segnato la comunità di origine africana. Sapere di poter essere ucciso senza alcun motivo, essere impotenti di fronte a un’ingiustizia subita, vivere nella miseria e nell’indifferenza totale, sentirsi prigionieri in Italia senza alcun diritto, neppure quello alla salute, ha fatto crescere in loro la diffidenza e la rabbia, insieme a uno spirito di vendetta verso sfruttatori e razzisti, e più in generale verso la società italiana. Questa rabbia è esplosa in rivolte puntuali, a seguito di eventi eccezionali, che sono andati ben oltre la quotidiana umiliazione, fatti che hanno violato oltre ogni misura la dignità delle persone e per i quali hanno ritenuto necessario reagire con violenza. Queste rivolte hanno reso la comunità africana più consapevole delle proprie forze e sono servite a dimostrare agli italiani quale potenza distruttrice essa è in grado di mettere in campo. Tanto, questo è il ragionamento di molti, non c’è più niente da perdere. Non si tratta, come qualcuno ha sostenuto, di prove di forza tra organizzazioni criminali, quelle italiane contro quelle nigeriane. C’è qualcosa di più profondo che accomuna questi ragazzi e che li fa agire insieme come un’unica forza dirompente, qualcosa che ha forse origine nei viaggi che compiono per arrivare in Italia e che, sicuramente, si rafforza qui con le discriminazioni che subiscono e con l’impotenza di fronte a una condizione ben diversa da quella che avevano sognato di raggiungere.
Il ripiegamento delle comunità
Gli episodi che hanno visto come vittime gli immigrati, hanno influenzato notevolmente il modo di abitare della comunità africana lungo la Domitiana, che negli ultimi anni ha preferito mimetizzarsi o spostarsi in luoghi più periferici e meno visibili, dove è più facile proteggersi da azioni criminali e nascondersi al controllo delle forze dell’ordine. Un segno di questa tendenza è l’apertura di numerosi luoghi di ritrovo in case private, che gli immigrati usano frequentare per mangiare, bere e passare il tempo libero insieme ad altri connazionali. L’apertura di bar, ristoranti, ma anche di tanti spacci di prodotti alimentari e per la casa, sta dando forma a una città nella città, governata da regole proprie e con una economia indipendente. Una sorta di enclave costituita non da un unico territorio, ma da tanti piccoli luoghi diffusi a macchia di leopardo e permeabili solo agli immigrati.
Questa involuzione è l’esito di un processo di esclusione e ghettizzazzone che ha però origini molto lontane nel tempo. Si tratta di un fenomeno purtroppo non ancora studiato e analizzato attentamente. Noi tutti dobbiamo fare lo sforzo di non generalizzare identificando la comunità africana solo con il giovane immigrato che lavora nei campi o nell’edilizia, con la donna che si prostituisce lungo la Domitiana, con il trafficante internazionale di droga o con il piccolo spacciatore locale. La comunità di origine africana che vive lungo la Domitiana è molto complessa e articolata. C’è chi è arrivato in Italia negli anni Settanta, chi è nato qui e chi vi è arrivato da pochi mesi. Chi dunque abita nel nostro paese da più di trent’anni e ha vissuto gran parte della propria vita qui. Chi è italiano a tutti gli effetti, anche se non ha ancora i documenti. E chi invece è appena arrivato e in molti casi è solo di passaggio. Inoltre, esistono tante piccole e grandi comunità: quelle nazionali, quelle etniche, quelle religiose. Ognuna con una sua identità specifica fatta di valori, riti e tradizioni diverse. Un insieme eterogeneo che molto spesso genera divisioni e scontri al suo interno, ma che è accomunato dalle condizioni di vita, da una lingua comune, l’inglese, usata sempre più spesso per escludere più che per includere, ma sopratutto dalla distanza e diffidenza verso l’altro, ovvero verso noi bianchi italiani.
C’è chi ha un regolare permesso di soggiorno, che gli ha consentito di emergere dall’illegalità e di avviare un’attività imprenditoriale. La più diffusa e redditizia è l’esportazione verso il paese d’origine di prodotti italiani nuovi o usati. Ma ci sono anche attività pensate principalmente per i connazionali che vivono in Italia: supermercati di prodotti alimentari africani, negozi di oggetti e tessuti tradizionali, ristoranti, bar e locali di ritrovo.
Chi invece non ha ancora un permesso di soggiorno, nonostante sia da molti anni in Italia, è costretto a vivere nell’illegalità continuando a lavorare in nero o avviando attività di tipo informale. Per esempio, molte donne, e tra queste anche quelle che in passato si prostituivano, gestiscono piccole attività commerciali in casa – spacci, ristoranti e bar – che gli consentono di avere un misero reddito per pagare l’affitto e sopravvivere. Mentre tra gli uomini c’è chi continua a cercare lavoro come manovale, oppure chi ha smesso da tempo di cercare e per guadagnarsi da vivere fa il meccanico, l’autista, il sarto, il barbiere o il fotografo, lavorando solo per la comunità. C’è chi lavora onestamente, nonostante una paga misera e l’assenza di diritti, e chi invece svolge attività illegali, come il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione. Ci sono donne che per anni sono state costrette a prostituirsi per pagare il debito contratto con il loro sfruttatore e che oggi sono diventate a loro volta delle madame che fanno prostituire giovani connazionali, per strada o in locali chiamati connection house, frequentati solo da africani.
Ci sono poi numerose famiglie, alcune costituite da persone della stessa comunità e fede religiosa, altre da persone di diversa nazionalità, e tra queste ce ne sono alcune composte da italiani e africani, altre ancora da persone di differenti religioni. A volte si tratta di rapporti non formalizzati né comunicati e accettati dalle reciproche famiglie di provenienza, nati a seguito di gravidanze indesiderate che la donna decide di portare avanti. In molti casi però l’arrivo di un figlio interrompe la fragile relazione e l’uomo abbandona la donna al proprio destino. Sono numerose le donne che crescono i propri figli da sole, oppure li affidano a connazionali che dietro un piccolo compenso si prendono cura dei bambini. In passato si usava affidare i bambini alle famiglie italiane, mentre negli ultimi anni si preferisce sempre di più portarli in Africa o affidarli a membri della propria comunità di origine.
Ci sono i ragazzi che fanno parte della cosiddetta seconda generazione, cioè figli di immigrati nati in Italia. Tra i più grandi e fortunati c’è chi va all’università o chi è già laureato. Anche loro però sognano di andarsene, in Inghilterra o negli Stati Uniti, da parenti o amici di famiglia, sfruttando semmai il fatto che parlano bene inglese. La loro è una condizione particolare. Nonostante non siano mai stati in Africa, non abbiano nulla in comune con i loro coetanei appena arrivati in Italia in cerca di lavoro, vengono spesso accomunati a questi ultimi e trattati allo stesso modo. Come spesso accade, i figli degli immigrati vivono un doppio conflitto, sono distanti dal modo di pensare dei genitori, con cui condividono una vita di stenti, ma non sono del tutto integrati con la comunità locale, con cui convivono in un territorio privo di servizi e spazi di aggregazione.
Infine ci sono i disperati, gli ultimi, anziani e giovani, in maggioranza uomini, ma anche donne. Gli anziani sono forse quelli più fragili. Hanno vissuto in Italia per molti anni, al sud, al centro e al nord. Hanno lavorato molto, prima in modo precario e poi con un regolare contratto. Con il lavoro hanno ottenuto un permesso di soggiorno. Poi con la crisi hanno perso tutto. Non hanno potuto rinnovare i documenti, non sono riusciti a trovare un nuovo lavoro e si sono rifugiati a Castel Volturno, dove abitano in case abbandonate e vivono di elemosina. Per loro non c’è speranza, non c’è futuro, c’è solo un passato fallimentare che ritorna continuamente alla mente. Vorrebbero tornare al paese d’origine ma la loro dignità li trattiene qui: non vogliono tornare da perdenti.
I giovani invece sono arrivati quando la crisi era già molto profonda, quando era difficile trovare un lavoro e quasi impossibile ottenere un permesso di soggiorno che gli avrebbe consentito di raggiungere un altro luogo e avere una vita più dignitosa di quella attuale. Si sentono prigionieri e si percepiscono come vittime della nostra società. Molti di loro si rifugiano nell’alcol, mentre altri si rinchiudono in se stessi e accusano gravi problemi mentali. Anche loro vivono in case abbandonate, senza acqua ed elettricità. A volte li si vede aggirarsi in gruppi di tre o quattro persone. Sono gruppi spesso violenti e pericolosi, saccheggiano le case disabitate e aggrediscono i loro connazionali. A causa di questa loro condizione sono spesso utilizzati come manovalanza per attività illecite.
Cosa fare?
Le istituzioni devono intervenire programmando e attuando politiche capaci di affrontare i numerosi bisogni emersi. È necessario riconquistare la fiducia di coloro che si sentono emarginati e abbandonati a se stessi; bisogna colmare la distanza che separa le varie realtà locali e le istituzioni, evitando che questa condizione di disagio cresca e che l’odio e la disperazione portino a nuovi tragici fatti di cronaca.
Per tutti il permesso di soggiorno è la prima necessità. Non si può più consentire che migliaia di persone siano costrette a vivere nell’ombra, in zone franche come sono gli insediamenti lungo la costa domitia, senza alcun diritto, sfruttati dai datori di lavoro quando hanno la fortuna di trovare un impiego. Bisogna prendersi cura di loro. La crisi economica, la mancanza di lavoro, l’assenza di una prospettiva, sta rendendo questa popolazione sempre più fragile e dipendente da alcol e droghe. Sono sempre di più i casi di persone che si lasciano andare, che vivono in case abbandonate senza luce e acqua, che mangiano poco e male, e che infine muoiono di malattie il più delle volte facilmente curabili.
Bisogna prendersi cura dei più piccoli. Seguire con attenzione e continuità chi vive in condizioni di forte disagio, dando un sostegno concreto alla famiglie, quando questo è possibile, o affidando i minori a comunità familiari in grado di farli crescere lontani da violenze e abusi. Per i più grandi invece sarebbe necessario istituire delle borse di studio per consentire ai più bravi e volenterosi di proseguire gli studi.
Bisogna aiutarli a trasformare le fragili attività che sono riusciti a mettere in piedi da informali a formali. I piccoli artigiani, i commercianti, gli agricoltori di origine africana dovrebbero essere aiutati a emergere dall’illegalità con progetti specifici che mirino a rendere più strutturata e redditizia la loro attività. In questo modo si consoliderebbe una piccola economia che potrebbe essere da volano per altre attività imprenditoriali.
Bisogna ripensare al ruolo del terzo settore e alle politiche sociali che sono state promosse con il finanziamento delle istituzioni bancarie, perché si sono dimostrate discontinue e improduttive. Sempre più spesso, purtroppo, piuttosto che rispondere ai bisogni che di volta in volta emergono, si rincorrono nuovi finanziamenti con progetti che non hanno nessuna ricaduta sul territorio, ma che sono funzionali esclusivamente agli interessi dell’associazione o della cooperativa che li promuove.
Sarebbe importante istituire un osservatorio permanente sull’immigrazione, capace da una parte di raccogliere dati sul fenomeno migratorio che ha caratterizzato Castel Volturno e cambiato la sua composizione sociale, monitorando costantemente i processi in atto, e dall’altra di rispondere alle situazioni di fragilità e alla necessità di socialità attraverso servizi, incontri formativi, corsi e laboratori ludico-didattici. Uno strumento capace di orientare la pianificazione della pubblica amministrazione verso una città inclusiva, pensata anche per la comunità migrante.
Infine è necessario intervenire sul territorio. I piani urbanistici, regionali e locali, devono tener conto delle comunità che abitano questi insediamenti. I politici, i tecnici, i progettisti non possono più far finta di nulla, negando la realtà e continuando a considerare questi luoghi come villaggi turistici di seconde case. Questo pezzo di territorio va considerato come il lembo residenziale più estremo dell’area metropolitana di Napoli. Non dico di abbandonare del tutto la natura turistica dell’area, ma di trovare un equilibrio tra l’origine di questi luoghi e la realtà attuale, portando nuove funzioni pubbliche, realizzando spazi di aggregazione, rompendo la trama delle lottizzazioni che crea tanti piccoli condomini separati l’uno dall’altro, senza alcun servizio, promuovendo un piano di recupero e trasformazione degli edifici abbandonati e dei lotti inutilizzati che potrebbero tornare a essere coltivati o trasformati in un sistema di parchi diffusi in tutto il territorio.
Questo progetto di riqualificazione potrebbe avere come protagonisti proprio gli immigrati di origine africana, ai quali si potrebbe chiedere di partecipare attivamente dando in cambio spazi abitativi, locali per le attività artigianali e luoghi di aggregazione. Non è utopia, ci sono diversi esempi virtuosi da prendere come riferimento.
[1] Era già successo nel settembre del 2008 quando, dopo l’uccisione di sei ragazzi africani da parte del gruppo criminale guidato da Giuseppe Setola, quando il ministro dell’interno Maroni aveva inviato a Caserta quattrocento uomini delle forze dell’ordine e cinquecento paracadutisti della Folgore.