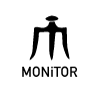Riletto dopo anni, questo libro ancora sorprende, quasi come un Om, un rumore di fondo a cui aggrapparsi per non naufragare nel pensiero unico sulla scuola, una voce che senza urlare ci dice che un altro sentimento educativo, più attuale e necessario, è ancora possibile. Un sentimento che si condensa intorno alla relazione con i ragazzi che ci affanniamo a definire “a rischio”, “difficili”, ma che ben presto ci allena a guardare diversamente tutta l’adolescenza, anche quella all’apparenza dorata dei licei; ci allena a guardare a noi stessi, adulti ormai incapaci di guardarci dentro, e sofferenti per questa incapacità. Certo, “stare a sèntere” è possibile solo se sentiamo la sofferenza, e solo se siamo capaci di sentire che questa sofferenza è una voce, una voce potente, come un ultrasuono che solo orecchie allenate possono percepire come significante. Una voce che vuole interrompere il circuito dell’etichetta, il potere di dare nomi alle persone da parte di persone che nessuno ha delegato a essere la voce di altri. Quella voce – ed è la stessa cosa se si manifesta nell’urlo o nel silenzio dei ragazzi – parla delle persone che sono oltre gli standard, oltre i recinti dei “casi”, delle diagnosi e delle terapie. Stare a sèntere la sofferenza significa stare ad ascoltare le voci che ci dicono: mo’ vi diciamo noi qualcosa su di noi. La sofferenza non è solo un’informazione, un indizio di patologia, è il paziente che dice qualcosa di politico su di sé, descrive quale politica dovrebbe inaugurare la città, oltre e contro medicalizzazioni e classi differenziali e carità varie.
La grandezza di Insegnare al principe di Danimarca non sta per nulla nell’afflato con cui ci avvicina a un mondo che attraversiamo senza starlo a sèntere, anche se è lontanissimo dall’effluvio di baci perugina che le retoriche sulla relazione ci vomitano addosso. No, Carla ci ha insegnato anche a sfuggire alla melensaggine. Leggete piano, leggete attenti: c’è un mondo di pratiche, tanto minute quanto efficaci, alle quali attingere. Una disposizione pedagogica ricca di attrezzi. La “cassetta degli attrezzi” era metafora amata da Carla per sottolineare la ricchezza emotiva e strumentale dell’artigianato pedagogico; non un algoritmo, non una programmazione, ma un incontro, sempre e comunque, che si metteva, e ci metteva, in moto solo se l’altro, il ragazzo o la ragazza, cominciava, per quanto flebilmente, a parlare di sé; se solo allora, con questo gesto di riconoscimento, certificava la significanza dell’incontro.
Una lingua antica
Sèntere, come ci suggerisce il dizionario, è un ascolto che “include anche gli affetti dell’animo”. E questi affetti devono saper diventare parola. Chiunque legge il libro di Carla è colpito dalla qualità della parola. Ma non è una parola che trasmette informazioni o strumenti, la parola di un manuale. È una lingua che narra l’esperienza di un apprendimento degli adulti basato sulla capacità di stare a sèntere l’adolescenza.
La tesi è questa: più è lontana da ogni lingua specialistica sulla scuola o sull’adolescenza o sull’apprendimento, più la lingua del libro di Carla è potente, tanto più fa capire la profondità dell’esperienza, costruisce un sapere.
Non propongo un’analisi stilistica, ma un’attenzione alla lingua del libro, che, bellissima copia e superba rappresentazione, rimanda all’universo linguistico dell’esperienza dei maestri di strada; un’attenzione al suo emergere al di fuori delle frasi fatte, delle gergali lingue delle lobby degli esperti (i testimoni sono ben altro). Questo non significa che ci troviamo di fronte a una lingua ingenua; siamo, anzi, di fronte a una lingua antica, che affonda la sua potenza espressiva nella grande cultura di Carla. Una volta, suggerendo delle letture ai docenti Chance, Clotilde Pontecorvo disse: “Bisogna leggere ai margini”, intendendo dire che non era utile leggere gli specialisti. La lingua di Carla è addirittura a monte, conficcata nella grande letteratura (Dostoevskij, Leopardi, Ariosto, Gogol, Freud, Tolstoi, Winnicott, Ilich, Bruner, Bettelheim), che le consente di leggere l’universo adolescenziale meglio di ogni “pedagogese”. Solo una lingua così “inesperta” poteva raccontare l’esperienza di un incontro antropologico e linguistico perturbante.
La semplicità della lingua di Carla corre il rischio di non farci comprendere quanto invece la cultura e lo studio siano oggi necessari per costruire ipotesi, atteggiamenti e strumenti di intervento. È una lingua dell’approssimazione, dove l’approssimazione non è qualcosa di pre-scientifico, al contrario: è la scelta di prendere una strada laterale, l’unico modo per addentrarsi in un territorio che sembra troppo familiare, guardandolo dai confini e scoprendovi aperture, sconfinamenti, zone franche (Carla definisce Chance come una zona franca). La lingua dell’approssimazione è, come dice Carla, una lingua che apprende camminando. E questo è un insegnamento o, se volete, la suggestione di un metodo da trasferire.
Chance e la scuola normale
Carla pone il problema della irriducibilità dell’esperienza di Chance – scuola della seconda opportunità – alla scuola normale, e talvolta si esprime in termini apodittici: “La scuola ha messo in atto la sua reazione di rigetto non solo verso i ragazzi ma verso coloro che di essi si prendevano particolare cura su mandato della scuola medesima. E questo la dice lunga sulla vera natura dell’istituzione scolastica”. Oppure: “L’educazione è troppo spesso addestramento alla sottomissione e all’ipocrisia, qualità tipiche di quei ceti sociali che sempre sono i più disponibili ad affidarsi alle sicurezze del potere totalitario”.
Questa è una grande aporia che il libro testimonia: da un lato la sfiducia istituzionale, dall’altro un lavoro continuo, appassionato, per ottenere sempre il meglio, se non il successo. Il pessimismo non ha mai fornito alibi alla fuga o all’iper-dedizione ineffabile e individualistica. L’aporia è stata tenuta insieme dalla “moralità”, intesa come mores, come comportamenti, come comportamento cittadino per eccellenza; una moralità che riesce a contenere le oscillazioni.
Di fronte al sapere lineare, quantitativo e classificatorio (il monitoraggio, le anagrafi, ecc.) della scuola, c’è una esperienza che descrive il processo ondulatorio della conoscenza, così come ondulatoria, e quindi inclassificabile, appare l’adolescenza e il processo stesso di apprendimento (laddove “il tempo della scuola è predeterminato”). Di fronte al tempo della programmazione si erge il tempo della crescita individuale. La conoscenza è sempre sperimentale. Il prezzo che si paga “in termini psicologici, è un continuo ondeggiare tra illusione e delusione”.
Saper contenere questo moto ondulatorio, il flusso delle vite, delle relazioni, dell’apprendimento, non sono solo pregi e prerogative psicologiche di superman, come traspare dall’agiografia che talvolta imprigiona l’esperienza condannandola all’ineffabilità e all’eccezionalità. Sono doti organizzative. Doti di un’organizzazione che sa “governare l’inatteso” (è il titolo di un recente libro di Weick[1]), che si confronta con l’incertezza costitutiva del mondo che nessun sapere e nessuna prudenza possono eliminare. Non c’è nulla di più incerto dell’adolescenza e, ormai, della genitorialità.
Nel libro fa continuamente capolino la struttura organizzativa del progetto. Le pratiche degli educatori Chance, analoghe a quelle proposte ai ragazzi, si basano sul principio dell’imparare facendo e sulla possibilità di riflettere sulle pratiche. Riflettere, si badi, come squadra, come gruppo. Affinché ciò avvenga, e affinché ci sia apprendimento istituzionale, è necessario che ci siano tempi e spazi deputati alla riflessione, al contenimento delle emozioni, alla costruzione di una solidarietà di squadra, al sostegno all’esperienza e alla sistematizzazione dell’apprendimento. La riflessione e la discussione non hanno nulla a che fare con le dispute ideologiche, non vogliono maggioranza e minoranza; avvengono in spazi dove ognuno ha la possibilità di rielaborare se stesso e di costruire un sapere condiviso. Di questa competenza a costruire istituzioni di prossimità capaci di stare a sèntere, nessuno sa che farsene. È meglio trattare questo sapere come se fosse mago merlino, una bacchetta magica e non una pesantissima cassetta degli attrezzi.
L’esperienza dello stupore
Il libro narra la radicale e definitiva crisi dell’identità professionale del docente, arroccata sulle sue competenze disciplinari e pedagogiche; e lo fa chiedendosi continuamente se quella che si stava mettendo in piedi negli anni di Chance fosse una scuola o altro. (Era altro).
Zagrebelsky[2], in Sulla lingua del tempo presente, scrive che ci troviamo di fronte a una burocrazia linguistica che impone “la ripetizione continua e ossessiva dei medesimi stereotipi, siamo di fronte a parole in libertà vigilata”. Chi più ne ha più ne metta: ascolto, partecipazione, territorio, inclusione, standard… Ognuno si faccia il suo catalogo. Ognuno provi a chiedere: ma cosa significa? Di fronte alle parole assolute degli esperti, a un sapere già codificato, il libro irrompe con le parole relative (il relativo è proprio dei deboli perché è problematico); relative sia perché sono deboli, sia perché sono il frutto di una relazione, sono relative ad altre persone, a specifici contesti. Da un lato i protocolli dei casi, dall’altro le storie delle persone; per cui, per esempio, da un lato “nel linguaggio sociologico (le famiglie dei ragazzi) si chiamano famiglie multiproblematiche”; dall’altro, “nella pratica (l’incontro) significa un continuo ingorgo di parole, lamenti, richieste, sopraffazione”. Le etichette falliscono, non s’azzeccano bene alle persone. Di questa lingua abbiamo bisogno.
Il libro descrive l’avventura della parola, lo spazio e la didattica della parola, come un’esperienza fondante di qualunque avventura “eretica” nella scuola (è più in generale nella città). Come Carla dice in diversi punti, anche l’avventura di Chance era cominciata con la presunzione di possedere già le parole per affrontare la realtà dell’esclusione. Ma quello che successe fu che l’emozione prese il sopravvento sugli schemi. L’interpretazione già pronta dei comportamenti dei ragazzi era “spesso viziata da una sorta di pregiudizio sociologico per cui ogni azione dovesse ogni volta essere riportata alla somma delle disgrazie familiari e sociali, mentre un occhio più attento avrebbe visto in atto emozioni relative al presente”.
Il libro narra la caduta di questa chiusura, attuata attraverso l’uso del linguaggio codificato, della rappresentazione super-identitaria della figura del docente e dell’istituzione scuola, di fronte a un territorio sconosciuto, definito solo per negatività: analfabeti, esclusi, ignoranti… (Uno dei problemi, forse “il” problema, della scuola oggi è quello di continuare a rappresentarsi con un eccesso di identità e di superiorità rispetto ad altri modi di apprendere, e noi sappiamo che la malattia nasce sempre da un eccesso di identità e la scuola soffre di questo male).
Da subito, invece, a Chance non fu possibile tracciare un confine tra “io che so” da un lato e quelli da conoscere dall’altro; prese il sopravvento una situazione di apertura, di sorpresa. Riprendendo l’espressione da un colloquio con una madre (un grandioso capovolgimento dei “colloqui” a cui sono abituati i ragazzi), si trattava di stare a sèntere i ragazzi, qualcosa di diverso dall’ascolto, per quanto attivo lo vogliamo chiamare, se con questa espressione intendiamo solo una relazione di interpretazione e di risposta. L’insegnante Chance ha imparato “la dura arte del dialogo vero”. Che è poi l’arte della conversazione.
Se lo strumento principale – un esito che viene prima della conoscenza – della neo-lingua delle lobby e degli esperti è la classificazione, l’esperienza che il libro narra è invece l’esperienza dello stupore, del suo fondamento di “stupidità” di fronte a un incontro ricchissimo con gli ultimi della classe. “Alla domanda quale sia la parte più significativa del progetto Chance per i docenti, si potrebbe rispondere che esso offre all’insegnante l’opportunità inestimabile di ripartire dal grado zero della parola”, scrive Carla Melazzini. Senza stupidità non avrebbe potuto esserci stupore, senza stupore curiosità, senza curiosità cura. Né alcun apprendimento, anche degli adulti intendo. Insegnare al principe di Danimarca è un romanzo di formazione, un inno alla passione per l’ignoranza come passaggio fondamentale per l’apprendimento. Questo è valso a Chance, questo è indispensabile oggi.
[1] Weick K., Governare l’inatteso. Organizzazioni capaci di affrontare le crisi con successo, Raffaello Cortina, Milano, 2010.
[2] Zagrebelsky G., Sulla lingua del tempo presente, Einaudi, Torino, 2010.