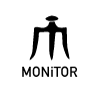Il tema delle attività d’impresa riconducibili a circuiti camorristi – o mafiosi in generale – è da tempo presente nelle analisi, nel dibattito e, di recente con maggiore ricorrenza, nelle cronache. Basta dare una scorsa alle notizie per verificare la frequenza di inchieste giudiziarie che puntano l’attenzione non solo sul livello criminale violento, ma su vasti intrecci affaristici in cui compaiono, in vario modo combinate, anche la componente imprenditoriale, quella politico-burocratica e a volte quella delle professioni. Da questo punto di vista, Mafia Capitale – l’inchiesta romana sulla cricca guidata dall’ex leader neofascista Carminati, in cui per la prima volta viene avanzata l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per una formazione non legata alle mafie tradizionali e operante a metà strada tra i livelli politico-amministrativi e il mondo criminale[1] – è solo la vicenda più eclatante di una lunga casistica.
Se facciamo eccezione per le inchieste strettamente riguardanti i gruppi di narcotrafficanti e spacciatori, le principali indagini degli ultimi anni delle direzioni distrettuali antimafia campane vertono tutte sul triangolo sopra richiamato: reti di cointeressenze tra boss o membri di gruppi violenti in senso proprio, ruoli economici e soggetti legati alla pubblica amministrazione. In genere, queste attività affaristico-criminali vengono presentate come se costituissero una trasformazione recente del fenomeno mafioso, la sua epigone attuale e “degenerata” (secondo una nota – e altrettanto ingenua – contrapposizione tra un passato mitico di principi etici e un presente ordinario di corruzione). Il mafioso sarebbe, secondo questa visione di senso comune, un capo violento che costruisce la sua reputazione, e quindi la sua leadership, all’interno della propria cerchia comunitaria (parentela, vicinato, compagnia dei pari), in genere collocata nei ceti sociali svantaggiati, e poi, in un secondo momento (o in una seconda fase storica), utilizzerebbe il suo potere intimidatorio per varcare la soglia della “società che conta” penetrando nella sfera dell’economia e dei mercati ufficiali. Un mondo nascosto e primitivo che – inquietante mutazione della modernità – tenderebbe a espandersi improntando di sé, e inquinandola, la parte visibile del mondo economico e le cerchie sociali superiori. Si può dire che la “narrazione ufficiale” del fenomeno mafioso sia tutta ricompresa entro questa dialettica tra underworld e upperworld. Nella parte conclusiva di questo intervento evidenzierò la parzialità di queste ricostruzioni che si basano sull’ottica – e sulla retorica – della legalità statale e dei dispositivi di repressione del fenomeno. Ma ci arriveremo per gradi. Vorrei ora discutere lo specifico delle formazioni che comunemente definiamo camorriste.
La genesi dei clan
In riferimento alla criminalità organizzata campana, l’attitudine imprenditoriale di singoli, gruppi, reti di alleanze tra soggetti diversi è particolarmente evidente. Rispetto alle altre mafie italiane, infatti, i gruppi di camorra, fin dalle prime manifestazioni storiche del fenomeno, agiscono su territori più densamente popolati, caratterizzati da mercati vivaci (per quanto marginali e periferici se considerati in un orizzonte più ampio di economia internazionale), siano essi di carattere legale (i principali riguardano prodotti della terra, trasporti, edilizia, magliareria e abbigliamento, agroalimentare, distribuzione commerciale, scommesse) o illegale (contrabbando, droga, prostituzione, gioco clandestino, ricettazione, usura). Si tratta di mercati di una certa dimensione, capaci di generare flussi considerevoli di valore e caratterizzati, per varie ragioni che qui non approfondisco, da sistemi di regole non univoci; regole derivanti in parte dalla normativa statale e in parte da accordi informali, pratiche di violazione o elusione della legge, vincoli di affiliazione e di sopraffazione, codici di comportamento legati al rispetto di gerarchie sociali. È all’interno di questo complesso quadro di scambi economici e di regole sociali che si affermano, in varie epoche storiche, i gruppi che, per la capacità di uso specializzato della violenza e l’attitudine al controllo sociale e del territorio, definiamo camorristi. I luoghi di formazione delle principali famiglie di camorra sono la città di Napoli (con le sue remunerative attività economiche illegali) e i principali centri di mercato in provincia (per esempio Nola, Giugliano, Marano, l’agro nocerino-sarnese, dove hanno storicamente sede importanti mercati ortofrutticoli e agroalimentari). I capi si impossessano, gradualmente e dall’interno, dei circuiti commerciali; costruiscono la loro posizione di dominio esercitando la violenza e l’intimidazione, ma anche negoziando.
In altri termini, dobbiamo considerare il clan di camorra, nella sua versione abituale (per intenderci, quella sancita e sanzionata dall’art. 416 bis), come il punto di arrivo, non di partenza, di un processo sociale di formazione. Dunque, non una variabile esogena che emerge da un mondo oscuro penetrando il mondo economico. Ma il frutto, il risultato dell’operare congiunto di fattori di ordine storico che favoriscono la trasformazione di un’attività imprenditoriale in attività mafiosa[2].
Vediamo qualche esempio storico. Nel primo periodo postunitario, come ci dicono i numerosi lavori storiografici disponibili sulla seconda metà dell’Ottocento[3], è soprattutto all’interno del settore dei trasporti (noleggio carrozze, mestieri legati al facchinaggio, rifornimento di biada e mangimi per animali da tiro) e dell’intermediazione dei prodotti agricoli, che troviamo le principali figure di capi violenti. Insieme ai mercati illeciti tipici di una grande città (gioco, prostituzione, usura, ricettazione, contrabbando di alcolici e tabacchi), questi ambienti rappresentano il contesto in cui alcuni soggetti intraprendenti e dotati di capacità di esercizio della violenza si impongono sugli altri.
Nel periodo dell’occupazione alleata e nell’immediato dopoguerra la formazione di famiglie criminali si realizza principalmente nei traffici clandestini tipici dell’economia segnata dalla catastrofe della guerra. In un noto lavoro dello storico inglese Hobsbawm, la figura del camorrista perde la caratterizzazione di leader di un gruppo mafioso per venire associata all’azione di vari tipi di operatori dei mercati attivi in quegli anni: truffatori, magliari, borsaneristi, contrabbandieri di tabacco e benzina, ma anche mediatori dei prodotti ortofrutticoli e fornitori delle pubbliche amministrazioni[4].
Ma è a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso che la genesi all’interno dei mercati di organizzazioni criminali via via più stabili è distintamente rilevabile. E certamente non è ininfluente la forte espansione dei consumi che proprio in quegli anni si realizza. I casi sono molti. Quella che viene considerata comunemente la prima figura di camorrista del dopoguerra, Pasquale Simonetti, è il dominus della borsa merci nei pressi della stazione centrale di Napoli, dove riveste il ruolo di “presidente dei prezzi”. Una decina d’anni più tardi si afferma il gruppo di Alfredo Maisto, boss di Giugliano, che di mestiere fa il mediatore d’automobili e la cui famiglia controlla il mercato ortofrutticolo locale. Vittorio Nappi, il mentore di Raffaele Cutolo, componente di una famiglia benestante gestisce attraverso il fratello il mercato ortofrutticolo di Scafati[5]. Tutta la nuova generazione camorrista, emersa negli anni Ottanta dopo la sconfitta di Cutolo, è costituita da contrabbandieri e imprenditori-commercianti che si impongono sulla scena criminale grazie alla gestione di mercati legali e illegali. In provincia, a Giugliano, abbiamo i rivali e poi successori di Maisto, i Mallardo, in origine commercianti del settore alimentare e più di recente insediati nella grande distribuzione dei prodotti elettronici. Quella tra le due famiglie giuglianesi è una faida che si sviluppa nel lungo periodo: c’è traccia nelle carte del tribunale penale presso l’Archivio di Stato di Napoli di scontri già all’inizio del Novecento. Una lunga storia tra due famiglie violente, che occupano una posizione di relativo prestigio nella società locale: dunque niente a che fare con soggetti emarginati che realizzano la scalata criminale.
In provincia troviamo ancora la famiglia Nuvoletta di Marano: il fondatore del clan, Lorenzo, è un commerciante ortofrutticolo e poi successivamente imprenditore edile. A Nola si impone nel dopoterremoto Carmine Alfieri, considerato in quegli anni il boss più importante della provincia di Napoli: prima di diversificare i suoi interessi economici in una pluralità di settori, è un commerciante di carni. Dal canto loro i Casalesi, con Bardellino prima e poi con le famiglie Schiavone e Zagaria, hanno una lunga tradizione di impresa in vari campi: edilizia, agroalimentare, commercio, rifiuti, immobiliare, scommesse, gioco d’azzardo. E, si badi bene, non come estorsori in senso proprio, piuttosto come operatori economici attivi già prima dell’ascesa criminale, che esercitano il dominio violento sulla concorrenza ricorrendo “anche” allo strumento estorsivo.
I clan cittadini, invece, sorgono in una dimensione maggiormente segnata dai traffici irregolari e illegali. I Giuliano costruiscono la loro fortuna nel rione Forcella, la più importante centrale di affari clandestini della città nel dopoguerra. I Licciardi di Secondigliano hanno una lunga tradizione nel settore della magliareria. I Mazzarella-Zaza presidiano le rotte del contrabbando grazie al controllo della fascia costiera cittadina, da San Giovanni a Santa Lucia. Finanche Giuseppe Misso, il boss della Sanità, figura sui generis di camorrista, fortemente connotato ideologicamente e vicino all’estrema destra, è in realtà un commerciante di calzature e pelli[6].
Beninteso, la dimensione dei mercati nella genesi dei gruppi di criminalità organizzata non è applicabile solo al caso delle “camorre”. Anche nella Conca d’oro attorno Palermo e nella piana di Gioia Tauro (altre due economie territoriali caratterizzate da mercati dei prodotti della terra vivaci e con notevoli quote di esportazione) vanno formandosi nel secondo dopoguerra gruppi che poi, nella stagione di maturazione dell’antimafia, verranno definiti come formazioni di Ndrangheta e di Cosa nostra. Ma è indubbio che le formazioni calabresi e siciliane abbiano caratteri maggiormente legati al gruppo chiuso, comunitario, con rituali di affiliazione, stabilità dei ruoli direttivi, ecc. A parte alcuni casi, invece, nella camorra non ci sono rituali di affiliazione e stabili organigrammi di gruppo. Non è un caso che, per definire le aggregazioni calabresi e siciliane, si utilizzino termini specifici (rispettivamente ‘ndrine e cosche), mentre nel caso della camorra si faccia riferimento al termine meno connotativo di clan (che in senso antropologico indica un gruppo parentale).
La famiglia e l’impresa
Con lo sguardo lungo della storia, le due componenti che possiamo considerare ricorrenti nei casi di “successo” di gruppi di camorra sono la famiglia – ampi fronti parentali che nei casi più importanti possono raccogliere lungo più generazioni centinaia di membri – e l’intrapresa economica. Se analizziamo il succedersi delle formazioni criminali campane sulla scena possiamo notare un assetto basato su reti di rapporti, piuttosto che su gruppi strettamente definiti. Spesso la definizione dell’appartenenza è labile, tanto che soprattutto di recente la pubblica accusa incontra notevoli difficoltà nell’applicazione dell’art. 416, che definisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso. All’interno di una singola famiglia possono formarsi coalizioni tra loro in guerra (come nei secondi anni Novanta e primi Duemila è capitato ai Giuliano di Forcella). Questo non vuol dire che non ci siano forme di affiliazione e fedeltà tipiche dell’appartenenza mafiosa, ma c’è un alto tasso di variabilità delle alleanze e di mobilità dei soggetti da una formazione all’altra. Peculiare è anche il fatto che spesso affiliati di alto grado differenzino i propri investimenti economici criminali, tanto da configurare una compresenza di attività individuali e di gruppo. Dunque il gruppo, per quanto costituisca il nucleo di potere forte, non sempre ha il carattere totalizzante verso i propri membri che ci aspetteremmo da una tipica formazione mafiosa.
Nel passaggio tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso intervengono due fattori a cambiare il panorama criminale campano e ad avvicinarlo a quello delle altre mafie italiane. Da un lato la crescita vertiginosa del traffico internazionale di stupefacenti, dall’altro l’espansione dell’economia pubblica con gli appalti del dopoterremoto. I reticoli di camorra si specializzano, diventano piccoli eserciti al soldo del boss, si assestano nella forma dell’affiliazione al gruppo, entrano in rapporto più stabile con la politica, scatenano vaste guerre con un numero di morti mai riscontrato prima (circa 2.000 nel solo decennio degli anni Ottanta e circa 4.000 tra gli anni Settanta e oggi).
Queste nuove caratteristiche contribuiscono a far immaginare i circuiti di camorra come gruppi militari, nuclei di potere antistatuali, centri di eversione, diversi per caratteristiche, ma collocati sullo stesso piano dei gruppi armati di matrice politico-ideologica. In parte, questa rappresentazione nasconde la natura essenziale del fenomeno: il governo dell’economia e l’intrapresa economica. Cosicché quando più di recente i gruppi di camorra tendono, nelle manifestazioni più potenti del fenomeno, a perdere la connotazione politica del gruppo armato e si presentano nella veste più consueta (potremmo dire più “tradizionale”) di reticoli affaristico-criminali, molti commentatori si lanciano nella scoperta della “nuova” natura imprenditoriale del fenomeno; la interpretano come una mutazione recente, ignorando il fatto che si tratta di un elemento specifico della genesi camorrista, e che semmai è la forma militare del gruppo chiuso a rappresentare un’eccezione, un tratto congiunturale dovuto alle particolarissime condizioni storiche.
Proprio per la sua natura di fenomeno legato all’attività economica d’impresa la criminalità organizzata campana, più di altre mafie, mostra un’alta variabilità di forme. Nel corso degli ultimi cinquanta anni è possibile individuare modelli organizzativi molto diversi tra loro[7]. Per esempio, la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo ha i tratti tipici dell’organizzazione di stampo fordista: il gigantismo (alcune stime parlano di 7.000 affiliati impegnati nella guerra, a cavallo dei primi anni Ottanta, contro la Nuova Famiglia), il centralismo, la retorica dell’appartenenza, una gerarchia interna di tipo piramidale, una sorta di ideologia sociale che promana dal carisma del leader. All’estremo opposto possiamo collocare il clan di Paolo Di Lauro – anche lui in origine, prima della scalata al mondo criminale, imprenditore attivo nel commercio di capi d’abbigliamento e poi capace di differenziare i propri investimenti in molti campi. La sua affermazione deriva dall’avere innovato profondamente il management del traffico di stupefacenti. Il modello consiste in una struttura reticolare con forte autonomia per i ruoli del clan dediti allo spaccio. I capi piazza organizzano i propri gruppi, sono indipendenti gli uni dagli altri, intascano tutto il ricavato della vendita e retribuiscono in proprio gli affiliati, con l’unico obbligo di approvvigionarsi esclusivamente dalla struttura direttiva che fa capo a Di Lauro. Per il resto sono imprenditori criminali che gestiscono un marchio, quello del clan Di Lauro, secondo una sorta di franchising[8].
Dentro i mercati
La letteratura sulla camorra, ma in generale sulle mafie, parte solitamente da una prospettiva “mafiocentrica”. Questo tipo di spiegazione, influenzata dagli studi criminologici e dalla prospettiva della legalità statale, interpreta le mafie essenzialmente nella loro dimensione politica di gruppo organizzato che nasce negli strati sociali svantaggiati (una sorta di autogoverno della plebe) e tende ad allargare la propria sfera di potere verso l’esterno. I gruppi mafiosi sarebbero dei contropoteri della società legale, dotati di confini netti, che agiscono contendendo il potere alle istituzioni statali o approfittando dell’assenza delle stesse; e che solo in tempi recenti, secondo un perverso percorso di modernizzazione, assumono una dimensione di impresa. Si tratta di una prospettiva non del tutto infondata ma certamente parziale, che trascura alcuni tratti essenziali dell’agire mafioso, presenti fin dalle origini. Semplificando, possiamo dire che questa visione ufficiale – che distoglie il fuoco dagli aspetti di impresa violenta del fenomeno – è dovuta a due ragioni principali. In primo luogo, una ragione di ordine ideologico (in senso tecnico) connessa alla costruzione del discorso nazionale e all’azione dei dispositivi dell’ordine pubblico, da cui deriva una rappresentazione dei gruppi di camorra come espressione di una “società segreta popolare, il cui fine è il male[9]”. In secondo luogo, per una ragione che attiene alla metodologia dell’analisi scientifica attorno a questi temi. Le fonti su cui si basano gli studi sono costituite principalmente – quando non esclusivamente – dalla documentazione giudiziaria, che per sua natura tende a selezionare gli aspetti della realtà che riguardano i reati violenti e che portano alla dimostrazione dell’esistenza del gruppo criminale organizzato.
È opportuno che l’analisi storico-sociale tenga conto della parzialità dei discorsi che si costruiscono intorno a questi fenomeni. Ciò consente di considerare con maggiore distacco e secondo un quadro più completo i circuiti violenti che danno vita a formazioni camorriste, includendo anche gli elementi negoziali e consensuali. A questo scopo risulta cruciale la dimensione economica e di impresa di questi circuiti. I gruppi di camorra prendono forma principalmente come reti di controllo all’interno dei mercati illegali e legali. Si può dire che il gruppo organizzato sia una variabile dipendente, una condizione di arrivo e non di partenza dell’attività criminale. Il gruppo camorrista in senso stretto non precede le attività, sorge invece come fattore d’ordine di mercati già caratterizzati dall’utilizzo della violenza (o dell’intimidazione) come forma di regolazione dei rapporti economici.
[1] Martone V., “Le camorre ‘oltreconfine’. Clan, società locale e rappresentazioni pubbliche nel Basso Lazio”, in Brancaccio L. e Castellano C. (a cura di), Affari di camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali, Donzelli, Roma, 2015, pp. 87-117.
[2] Brancaccio L., “Mercati violenti e gruppi di camorra”, in Brancaccio L. e Castellano C. (a cura di), Affari di camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali, Donzelli, Roma, 2015, pp. 5-44.
[3] Marmo M., Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l’Unità d’Italia, l’ancora del mediterraneo, Napoli, 2011.
[4] Hobsbawm E. J., I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, Torino, 1966, basato sulle informazioni di prima mano raccolte in Guarino C., “Dai mafiosi ai camorristi”, in Nord e Sud, II, 13, 1955, pp. 76-106.
[5] Sales I., Le strade della violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli, l’ancora del Mediterraneo, Napoli, 2006.
[6] Baglivo A., Camorra S.p.A. Droga, omicidi, tangenti a Napoli: dai contrabbandieri del golfo ai boss in doppiopetto, Rizzoli, Milano, 1983; Di Fiore G., La camorra e le sue storie. La criminalità organizzata a Napoli dalle origini alle ultime «guerre», Utet, Torino, 2005.
[7] Brancaccio L., “Paese che vai, clan che trovi”, in Limes. Rivista Italiana di Geopolitica, n. 11/14, 2014, pp. 131-141.
[8] Di Meo S., L’impero della camorra. Vita violenta del boss Paolo di Lauro, Newton Compton, Roma, 2008.
[9] Benigno F., La mala setta. Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, Einaudi, Torino, 2015; la citazione è tratta da Monnier M., La camorra: notizie storiche raccolte e documentate, Introduzione di Gribaudi G., Argo, Lecce, 1994 (edizione originale 1862).