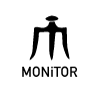Il 23 novembre 2010, in occasione del trentennale del terremoto in Irpinia, Conchita Sannino intervistò Andrea Geremicca, allora plenipotenziario del Pci a Napoli. “Se oggi un urbanista dovesse indicare a uno studente tracce di quel 23 novembre 1980 nell’area metropolitana di Napoli – scriveva la giornalista –, dovrebbe prenotare un viaggio nel post-terremoto delle vite degli altri. Quello che venne battezzato come Piano Napoli, poi trasformato in legge 219. La catastrofe che doveva diventare occasione per colmare la fame abitativa di Napoli. E che invece creò le cattedrali del disagio cronicizzato. Ventimila alloggi, oltre centomila vani, che dopo tre decenni restano l’eredità più pesante. Autentiche bombe sociali piantate, come una cintura di kamikaze, tutte intorno ai bordi di Napoli e degli altri diciassette comuni che le facevano da via di fuga cementizia. Sono nati allora i mostri di oggi. Taverna del Ferro, il Bronx di Napoli. Rione Salicelle, girone infernale di Afragola. Parco Verde a Caivano, il quartiere con la più alta densità di malavita minorile. La 219 di Melito, succursale dello spaccio degli scissionisti a Scampia. E così via, fino alle cronache di questi giorni, con le palazzine del Piano Napoli di Boscoreale che forniscono rabbia sociale alla rivolta di Terzigno contro la discarica. ‘Che cosa non ha funzionato? Intanto, non avevamo strumenti urbanistici definiti, oggi diremmo integrati, se non i piani di edilizia di zona, che ci dicevano già in quali aree mettere le mani. Poi non avremmo dovuto aggregare solo i ceti più poveri ed emarginati. Dovevamo accompagnare questa roba con un piano di sviluppo economico, invece volemmo il maledetto e subito!’, sottolinea Geremicca[1]”.
Il territorio dell’oblio
A differenza di quanto accade per la ricostruzione nella città di Napoli – che nei documenti e nelle relazioni ufficiali viene presentato come intervento esemplare – il racconto di quel che avvenne nell’area metropolitana si concentra sulle pratiche di natura clientelare e speculativa che hanno caratterizzato la costruzione delle grandi infrastrutture (acquedotti, bonifiche, collettori, depuratori, assi stradali). L’area metropolitana viene definita come territorio della “seconda ricostruzione”, quello in cui viene messa in opera la “svolta infrastrutturale[2]”. Un racconto che non ha origine negli insediamenti residenziali realizzati con la legge 219 del 1981, ma qualche anno dopo. A partire dal 1983 il dispositivo legislativo delle “avocazioni” permette ai commissari di estendere ai concessionari che realizzano le residenze per i terremotati altre opere infrastrutturali, non previste dalla 219 ma considerate funzionali alla ricostruzione. L’area metropolitana diventa così il luogo dove si accumulano strade, autostrade, svincoli, raddoppi, bretelle, fognature, depuratori e altre grandi opere, dove finirà per contare di più la costruzione di una rete clientelare via fondi pubblici, che la volontà di organizzare funzionalmente la dimensione metropolitana del capoluogo. L’immagine che caratterizza la ricostruzione in area metropolitana si cristallizza così in quella “economia e partito della catastrofe” che emerge dalla collusione tra politici e imprenditori e dall’enorme dissipazione di risorse pubbliche[3]. Una rappresentazione che diventa fulcro dell’attenzione e luogo sociale della memoria del terremoto.
L’oggetto di questa riflessione non è però questa immagine, ma quella di un territorio dove atterrano circa 37.500 terremotati provenienti da Napoli, ricollocati in quartieri spesso isolati, dislocati a corona del capoluogo. Si tratta di un territorio dell’oblio, costruito mediante dispositivi (slittamenti, sostituzioni di immagini, ricostruzioni, commemorazioni) che sollecitano l’estinzione del ricordo e la rimozione, anche fisica, dei suoi abitanti.
Dalla coabitazione alla separazione dislocata
Il terremoto del 23 novembre 1980 investe tre regioni (insieme a Campania e Basilicata, le più colpite, anche la Puglia), coinvolge 679 comuni di otto province (Avellino, Salerno e Potenza quelle maggiormente sinistrate, e poi Benevento, Caserta, Napoli, Matera, Foggia), causa 2.735 morti, 8.850 feriti, 400 mila senzatetto, abbatte 77 mila costruzioni e ne danneggia altre 275 mila. A differenza della devastazione che avviene in Irpinia, a Napoli cade un solo palazzo, nel quartiere di Poggioreale, che trascina con sé 57 dei 69 morti in città (130 in tutta la provincia). Al di là delle tragedie umane, il terremoto disvela una situazione di forte disagio abitativo, accelerata e amplificata dalla scossa.
Nel capoluogo, prima del novembre 1980, circa 22.500 famiglie avevano richiesto l’assegnazione dell’alloggio pubblico (bando ’76-77): un piccolo esercito che occupava tutti gli interstizi disponibili (grotte, caverne, baracche, bassi) e/o viveva in condizioni di coabitazione e sovraffollamento (circa 3 abitanti per vano). A questi si aggiungevano ogni anno mediamente 250-300 famiglie sgomberate e circa 10 mila famiglie assistite, di cui 1.700 “senzatetto” e 800 con sfratto esecutivo. Dalla relazione governativa sull’equo canone del luglio 1980 risulta che Napoli deteneva, con Catania, il primato degli alloggi in condizioni scadenti (35,4%) e che nel 40% del territorio l’indice di affollamento era superiore a 1,5 abitanti per vano.
Con il terremoto si contano 35 mila edifici danneggiati di cui 5.500 pericolanti, si cumulano 3.200 ordinanze di sgombero totale, 1.750 di sgombero parziale e, al giugno 1981, 80 mila famiglie diventano “terremotate-senzatetto[4]”. Da una situazione di disagio la città passa, in una sola notte, a una condizione di emergenza abitativa. Così Napoli diventa l’“eterna fabbrica di senzatetto[5]”, il territorio si trasforma in spugna e inizia l’esperienza dell’abitare dislocato.
Un esodo coatto di circa 150 mila persone inonda il territorio, distribuendosi a casaccio e secondo le opportunità. Si contano 10 mila famiglie in ricoveri di fortuna (roulotte, vagoni ferroviari, ecc.), 3 mila famiglie in container (molti nel porto), 1.500 in alberghi, 800 in appartamenti requisiti in città, 1.800 case requisite nel litorale domizio, 2.400 famiglie in alloggi pubblici (tra ingressi e occupazioni si riempie la 167 di Secondigliano), 3.500 occupano 150 scuole e 1.300 si sistemano in altre strutture pubbliche. Si occupano tutti i padiglioni della Mostra d’Oltremare, nei giardini si allestisce un campeggio, circa 1.100 persone vengono sistemate in tre navi ormeggiate nel porto dove si pratica l’esperienza di stare “tutti sulla stessa barca”.
Qualche mese dopo, alla coabitazione in strutture pubbliche si sostituisce la separazione dislocata e temporanea. Inizia l’esperienza dell’abitare in alloggi precari. Si tratta di abitazioni transitorie, distinte in container – (4.680 in area metropolitana, di cui 2.538 nel capoluogo) – e prefabbricati bipiani – (5.166 tra Napoli e l’area metropolitana). I prefabbricati vengono organizzati in 50 campi tra Napoli e provincia, ribattezzati poi dai, gruppi organizzati, “campi di concentramento”.
Il litorale tra Napoli e Caserta, luogo a vocazione turistica, con il terremoto cambia la sua storia. Nel 1981, sotto la pressione dei comitati, il Commissariato straordinario di governo requisisce le “seconde case” per ospitare le famiglie dei terremotati-senzatetto. Si tratta di edifici e villette spesso abusive distribuite tra la strada della Domiziana e il mare. Da un lato, l’invasione dei terremotati napoletani riempie i posti lasciati liberi da un turismo mai del tutto decollato, rende lecita e condonabile la costruzione abusiva in un territorio mai progettato e assicura ai proprietari affitti sicuri da parte dello stato. D’altro canto, l’abitare dislocato si presenta come presagio di una ricollocazione abitativa lontana da Napoli. Si concentrano così povertà e precarietà, e si genera una popolazione circolante su tutto il territorio investito. Da quei luoghi, infatti, i terremotati ritornano quotidianamente nel centro storico di Napoli, chi per lavorare, chi alla ricerca di un posto ricco di oggetti del passato in cui riconoscersi. Si trasformano in spugne anche Castel Volturno, Mondragone, Villa Literno. Dal terremoto in poi questi luoghi diventano il cuscinetto assorbente tra la grande città e il resto del territorio, su cui adagiare l’esodo e lo scarto, locale e non.
Nel dramma che vive la città, con una mobilità di ricovero abitativo che si spinge sempre più verso l’esterno dei confini comunali, le opposizioni si trasformano in conflitti. Il terremoto fa emergere nuove figure sociali. Accanto agli storici “disoccupati organizzati” ecco i “senzatetto organizzati” e i veri e propri terremotati che, nel chiedere alloggi e lavoro, veicolano la lotta contro una nuova parola: deportazione. Una parola che coniuga il trauma collettivo della perdita dell’abitazione e della frattura dei legami sociali e identitari con uno scetticismo diffuso nei confronti delle istituzioni.
All’immagine della deportazione si contrappone quella tecnica del “decongestionamento” del capoluogo, sempre più necessario all’interno di una visione territoriale articolata. In modo parallelo al conflitto sociale, si genera così una discussione sulla possibilità di utilizzare la ricostruzione come occasione per un riequilibrio territoriale, costruendo un’area metropolitana moderna caratterizzata da servizi e infrastrutture[6]. Tra deportazione e decongestionamento la legge per la ricostruzione (n. 219 del maggio 1981) si presenta come dispositivo istituzionale del trattamento della catastrofe.
L’attuazione della legge 219
La legge per la ricostruzione post-terremoto disciplina al titolo VIII la realizzazione di un Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica (Pser) per oltre 20 mila alloggi da ripartire tra Napoli e la sua area metropolitana, secondo tempi e procedure eccezionali. Vengono nominati due commissari straordinari, il sindaco per il capoluogo e il presidente regionale per gli interventi in area metropolitana. La decisione di come e dove localizzare gli alloggi viene affidata al sindaco il quale, in pochissimi giorni e in base al dimensionamento sul capoluogo, ripartisce la quota in circa 13 mila alloggi (circa 58.200 abitanti) da realizzarsi nel capoluogo e 7 mila alloggi (circa 37.500 abitanti) nell’area metropolitana.
A Napoli la ricostruzione diventa l’occasione per ricondurre lo straordinario nell’ordinario, attuando le scelte già operate dall’amministrazione. Oltre a interventi puntuali e diffusi (56 interventi di recupero urbano in centro storico, 470 alloggi di edilizia sostitutiva e 162 di recupero edilizio) la ricostruzione assume due filosofie, una relativa all’attuazione dei piani di espansione (si portano a termine due piani di zona, la 167 di Secondigliano con 418 alloggi e la più consistente 167 di Ponticelli con 3.988 alloggi) e l’altra volta al recupero e alla riqualificazione urbana. Qui l’ossatura del piano di ricostruzione è l’attuazione del Piano delle periferie (adottato nell’aprile dell’80 dalla giunta comunale Valenzi), che al recupero di 13 dei 33 casali antichi della città (ovvero di 2.660 alloggi) affianca la realizzazione nelle adiacenze di nuove residenze (per circa 5.880 alloggi). Alle residenze si affianca la realizzazione di attrezzature e servizi, dimensionati non in base ai residenti da insediare, ma al più vasto territorio periferico in cui gli interventi sono inseriti. L’operazione è a “bilancio chiuso”, ogni intervento di recupero e nuova edilizia non prevede, in linea di principio, né aumenti né espulsione degli abitanti. L’intervento del Pser a Napoli si presenta come “il più importante tentativo fatto nell’Italia repubblicana per collocare un intervento pubblico d’emergenza in una corretta cornice urbanistica; per collegare tra loro restauri, ristrutturazioni e nuove edificazioni; per attivare procedure amministrative e apparati tecnici adatti all’emergenza, ma trasformabili in strutture stabili e normali[7]”.
Su scala metropolitana la localizzazione dei nuovi insediamenti, per complessivi 7 mila alloggi, avviene attraverso la ricerca di disponibilità nei comuni della prima fascia esterna al capoluogo. Anche qui, la realizzazione segue la logica di rendere attuative le scelte preesistenti nei diversi comuni, che avevano destinato parti di territorio a piani di zona dove realizzare edilizia economica e popolare. Una logica che conduce a ricercare una dimensione territoriale in grado di assorbire gli “effetti sociali” dell’operazione. La dimensione scelta sarà quella omogenea e istituzionalmente definita delle Unità sanitarie locali. In tal modo, gli effetti sociali verranno riformulati e gestiti come servizi sanitari, operando una sorta di “sanitarizzazione” del disagio.
Dalla selezione dei comuni di approdo, vengono esclusi quelli della penisola sorrentina, che costituiscono la riserva di pregio della città (oltre che terra di origine di molti politici nazionali), mentre entrano tutti quelli a nord, al confine con la provincia di Caserta. La Campania interna diventa così la principale direttrice di localizzazione del disagio, a grappoli e fasci di espansione, senza una strategia chiara di quale sia la direttrice principale. Infatti, mentre si individuano a livello di piano alcune direttici (quella puteolana-giuglianese a ovest, quella aversana a nord; quella nolana a est e quella vesuviana a sud), l’immagine che ne risulta è chiaramente orientata a riempire le aree libere lungo le due principali penetrazioni autostradali (nord ed est), secondo conglomerazioni a “galassia” (nell’area nord) e a “cometa” (lineare nell’area est), in cui si localizzano più del 75% degli alloggi da realizzare. Inoltre, la scelta delle aree, legata come si è detto alla previsione di piani di zona approvati, conduce a realizzare gli insediamenti ai margini dei comuni, alla periferia della periferia.
Si coniugano qui due immaginari disgreganti, quello della deportazione vissuta dai napoletani, sempre più isolati nelle abitazioni provvisorie (alberghi, case requisite, container), e quello della colonizzazione-invasione percepita dagli abitanti dei comuni ospitanti, che vedono sottratte aree per edilizia abitativa a favore di una popolazione che non gode di buona reputazione. A mitigare tale conflitto sarà da un lato l’incremento di una quota del 20% degli alloggi a favore della popolazione locale, con la speranza che questo basti a garantire un processo di integrazione con i nuovi abitanti, e dall’altro la promessa che questi insediamenti (21 in totale, in 17 comuni), opportunamente attrezzati, promuoveranno un effetto induttore di nuova urbanità sulle realtà circostanti. Effetto da sostenere anche attraverso il rinforzo di un ampio sistema infrastrutturale (principalmente tra Asse di supporto e Asse mediano, entrambi est-ovest). L’esito sarà devastante per alcuni piccoli comuni: San Vitaliano, per esempio, vede più che raddoppiare la sua popolazione, che incrementa di molto anche a Casale di Cisterna e Brusciano. Gli interventi complessivamente raggiungono i 7.704 alloggi, di cui 7.373 di nuova costruzione e 331 derivanti da interventi di recupero in alcuni centri storici (245 ad Afragola e 86 a Melito). Il rapporto tra numero di alloggi realizzati e popolazione trasferita viene calcolato in 6 persone per alloggio.
L’abitare dislocato
A partire dal 1985 si smantellano i campi container e i terremotati vengono trasferiti nelle nuove abitazioni realizzate in 17 comuni diversi. L’abitare dislocato, iniziato con l’emergenza, diventa la soluzione spaziale al trattamento del disagio abitativo di Napoli, accumulando con un’unica operazione vecchie e nuove precarietà, senzatetto e terremotati.
Esito di tale concentrazione è soprattutto il bando del 1983 del Cipe per l’assegnazione degli alloggi (i 20 mila della ricostruzione e gli 8 mila di edilizia popolare già realizzati prima del terremoto), con criteri di selezione che restituiscono la mappa sociale delle migrazioni forzate.
Il bando definisce gli abitanti in disagio abitativo a partire dalle esigenze complessive della ricostruzione e non dalle effettive condizioni dei terremotati-senzatetto. Si individuano sei categorie. Una corsia preferenziale viene data agli abitanti degli alloggi distrutti e/o degli alloggi soggetti a esproprio, che dispongono di una riserva di alloggi fino a esaurimento. Sono gli abitanti delle periferie interessate dal programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, che nella logica del “bilancio chiuso” rientrano nei loro territori riqualificati, occupando le case recuperate negli antichi casali o quelle di nuova realizzazione. Questa logica, se da un lato mantiene gli abitanti dei quartieri periferici nei loro luoghi di appartenenza, dall’altro avvia la migrazione forzata verso l’area metropolitana di tutti gli abitanti dei quartieri centrali della città, non interessati dagli interventi del programma. Si tratta di una vasta popolazione di senzatetto-terremotati (al bando per la categoria B, “abitanti di alloggi impropri quali bassi, baracche, scantinati, container, case requisite, alberghi”, rispondono 24 mila nuclei familiari, pari al 26,5% di tutte le domande) proveniente dai quartieri storici (Sanità, Forcella, Materdei, Quartieri Spagnoli), già distribuita in campi container, alberghi e alloggi requisiti.
Se la ricostruzione nelle periferie napoletane viene presentata come un’operazione volta a trasformare queste “da periferie a città”, quella sull’area metropolitana ribalta l’operazione “da città a periferia”, anzi alla periferia della periferia. Il vasto territorio a nord della città, a partire dal terremoto cambia la sua fisionomia. Attualmente in molti di questi rioni le attrezzature sono abbandonate o vandalizzate, alcuni di essi sono sottoposti a progetti di recupero (soprattutto piani di recupero urbano della legge n. 493/93 ad Afragola, Caivano e Casalnuovo), altri a iniziative di demolizione e ricostruzione (Quarto o Striano, insediamento questo abbandonato e messo all’asta). All’altissima disponibilità di attrezzature pubbliche, per contrasto si sovrappone la concentrazione del disagio e la diffusione della segregazione.
* Estratto da “Da città a periferia. Dinamiche dell’abitare dislocato”, in XIV conferenza Siu. Abitare l’Italia. Territori, economie, diseguaglianze. Torino 24-25-26 marzo 2011.
[1] Sannino C., “La notte in cui Napoli piantò il seme malato dei quartieri-ghetto”, in la Repubblica Napoli, 23/11/2010.
[2] Barbagallo F., Napoli fine Novecento, Einaudi, Torino, 1997.
[3] Barbagallo F., Becchi Collidà A., Sales I., L’affare terremoto. Libro bianco sulla ricostruzione, Angri, 1989; Becchi Collidà A., Napoli “miliardaria”. Economia e lavoro dopo il terremoto, Franco Angeli, Milano, 1984; Becchi Collidà A., “Napoli contro Napoli. Città come economia e città come potere”, in Meridiana, n. 5, 1989.
[4] Commissariato straordinario di governo, Il disagio abitativo a Napoli e nell’area metropolitana, Napoli, 1984.
[5] Cammarota O., Relazione all’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, dattiloscritto del 16 febbraio 1982.
[6] Cresm, Terremoto e crisi urbana, Cooperativa Sintesi, Napoli, 1981.
[7] Benevolo L., “Una valutazione critica del Programma Straordinario”, in ArQ n. 6-7, 1991.